| Roop Lal Sandhu | ||
| Scuola di Yoga |
Prefazione
PARTE PRIMA – CONOSCERE LO YOGA
Perché
lo yoga?
Le diverse vie dello yoga
Yama: le norme morali dello yoga
Yoga e igiene personale
A tavola con lo yoga
PARTE SECONDA – PRATICARE LO YOGA
Introduzione agli esercizi di hatha-yoga
Il
rilassamento
1.
Il rilassamento supino (sava-âsana)
2. Il
coccodrillo (makara-âsana)
3.
II rilassamento facile (jyestha-âsana)
4.
Il Buddha dormiente (sayana-Buddha-âsana)
5. La respirazione purificatrice e
rivitalizzatrice (anuloma-viloma-kriyâ)
6. II rilassamento yogico profondo (yoga-nidrâ)
Le tecniche yoga: âsana e prânâyâma
1°
livello
7. Il bastone
(danda-âsana)
8. La posizione
purificatrice (pavana-mukta-âsana)
9. Il
sollevamento del bacino (upastha-utthâpana-âsana)
10. II pesce (matsya-âsana)
11. La semi-cavalletta
(ardha-shalabha-âsana)
12. La folgore (vajra-âsana)
13.
La consapevolezza del respiro (introduzione al prânâyâma)
2° livello
14. Il sollevamento sulle braccia (purva-uttâna-âsana)
15.La tigre (vyâghra-âsana)
16. La torsione spinale (vakra-âsana)
17. La posizione del perfetto yogin (siddha-âsana)
18. L'albero (virksha-âsana)
19. La nave (nâv-âsana)
20. La respirazione a sezioni (vibhâga-prânâyâma)
3° livello
21. Il saluto (eka-janu-namaskâra-âsana)
22. Il coniglio (shasha-âsana)
23. La candela (sarva-anga-âsana)
24. Il cobra (bhujanga-âsana)
25. Lo stiramento laterale (parshva-uttâna-âsana)
26. La posizione di raccoglimento (dhârmika-âsana)
27. La respirazione completa (mahâ-yoga-prânâyâma)
4° livello
28. L'arco (dhanur-âsana)
29. Lo stiramento del dorso (pascima-uttâna-âsana)
30. II leone (simha-âsana)
31. Il cammello (ushtra-âsana)
32. Il triangolo (trikona-âsana)
33. L'eroe dormiente (supta-vîra-âsana)
34. La respirazione vocalica (pranava-prânâyâma)
5° livello
35. L'aratro (hala-âsana)
36. II cerchio (cakra-âsana)
37. La posizione testa-ginocchio (janu-shîrsa-âsana)
38. La cavalletta (shalabha-âsana)
39. La posizione di Goraksha (Goraksha-âsana)
40. La freccia (Vîrabhadra-âsana)
41. La respirazione alternata di purificazione (nâdî-shuddhi)
6° livello
42. L'estensione della gamba (Ananta-âsana)
43. II loto (padma-âsana)
44. La posizione di Matsyendra (ardha-Matsyendra-âsana)
45. La posizione sulla testa (shîrsha-âsana)
46. II pavone (mayûra-âsana)
47. La flessione in avanti (pada-hasta-âsana)
48. La respirazione a fasi eguali (samavritti-prânâyâma)
PARTE TERZA – TAVOLE FOTOGRAFICHE
PARTE QUARTA – LO YOGA DELLA MENTE
La
psicologia dello yoga
Esercizi di meditazione
Meditazione semplice
Meditazione sul
grembo universale (yoni-mudrâ)
Concentrazione sulla
fiamma (trâtaka)
Silenzio mentale
Meditazione di pace
Meditazione sull'aurora
Meditazione sul sé (âtma-vichâra)
Mare di luce
Meditazione sull'anâhata-chakra
Meditazione sul manipûra-chakra
Meditazione sul Maestro inferiore
Meditazione di trasformazione del corpo fisico
PASSI SCELTI
Oltre venticinque secoli prima dell’era cristiana, lungo il corso dell’lndo, nel territorio dell’attuale Pakistan, fiorì una civiltà altamente sviluppata, le cui vestigia sono state riportate alla luce dagli archeologi a partire dai primi anni del nostro secolo. Sono ormai noti a tutti i nomi di Harappâ e Mohenjo-Dâro, i luoghi dove sorgevano i più importanti centri della civiltà dell’lndo: qui la disposizione di edifici pubblici e case d’abitazione, costruiti con mattoni d’argilla, ubbidiva a un preciso piano regolatore e inoltre la città era dotata di una perfetta rete idraulica di canali di scolo. Questa civiltà possedeva una scrittura composta di pittogrammi che a tutt’oggi non sono stati decifrati, sebbene siano state avanzate varie interpretazioni, talora del tutto fantasiose, come quella che li ricollega alla scrittura, altrettanto misteriosa, dell’isola di Pasqua.
Gli scavi condotti nella valle dell’lndo hanno riportato alla luce una grande quantità di manufatti: vasellame, statuine di terracotta, ornamenti, e i famosi sigilli di pietra, per lo più steatite, recanti varie raffigurazioni simboliche. Alcune di queste rappresentano, con tutta evidenza, figure umane in posizioni yoga.
Questa disciplina, dunque, che prima delle scoperte archeologiche della valle dell’lndo si riteneva appartenesse al patrimonio culturale degli Arii, il popolo conquistatore che penetrò in India nella prima metà del secondo millennio, affonda invece le sue radici nella più antica civiltà di Harappâ e Mohenjo-Dâro, sicché la sua origine si perde nella notte dei tempi.
Quarantacinque secoli sono trascorsi dall’apogeo della civiltà dell’lndo: l’uomo ha messo piede sulla Luna e invia ormai i suoi sofisticati congegni a esplorare i confini del sistema solare. Nei laboratori di ricerca uomini di scienza scompongono facilmente l’atomo nelle sue particelle infinitesime, dove materia ed energia si confondono, mentre i biologi tentano di carpire alla cellula i suoi ultimi segreti. L’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo hanno cessato di essere qualcosa di misterioso e temibile. Anche l’uomo comune, cui sfuggono formule e leggi che a pochi è dato di elaborare e comprendere, vive però un’esistenza condizionata dall’assoluto predominio di una complessa multiforme tecnologia.
Non quarantacinque secoli, cioè meno di duecento generazioni, ma una distanza abissale sembra separarci dalla civiltà delI’Indo!
Eppure proprio in questi ultimi anni, i più intensi di scoperte scientifiche e di progresso tecnologico, uomini e donne si rivolgono con crescente interesse allo yoga, questo dono dell’Oriente antico che promette equilibrio, salute lucidità interiore, ma soprattutto liberazione dall’ansia e dal’insicurezza che, ad onta del progresso scientifico, o forse proprio in virtù di esso albergano nel cuore di ciascuno.
Si moltiplicano così i libri sullo yoga: alcuni di essi presentano una meccanica serie di âsana, o posizioni, prescindendo quasi del tutto dai principi etici e filosofici della disciplina; altri invece hanno l’ambizione di condurre per mano il lettore fino alle più alte realizzazioni dello yoga esoterico, incuranti del fatto che al di sopra di un certo livello ci troviamo di fronte a una dottrina iniziatica, la quale non può essere trasmessa da un testo scritto, ma richiede il diretto insegnamento e la costante assistenza di un maestro.
Questo libro intende fornire una corretta informazione a coloro che desiderano accostarsi alla disciplina dello hatha-yoga, cioè lo yoga fisico (o meglio psico-fisico), sia mettendone in chiaro i presupposti filosofici, senza i quali esso verrebbe degradato a semplice ginnastica, sia esponendo quelle tecniche fondamentali nelle quali un occidentale non iniziato può esercitarsi da solo senza alcun pericolo.
La prima delle quattro parti in cui è diviso il libro ha lo scopo di rendere familiare lo yoga: spiega perciò i motivi per i quali esso può essere utile all’uomo occidentale, quali sono i benefici che questi ne può ricavare e con quale abito mentale è opportuno accostarsi a questa antica disciplina.
Sempre nella prima parte vengono esposti i precetti morali (yama), che stanno alla base di ogni forma di yoga: in particolare viene esaminata la loro concreta applicazione alla vita dell’occidentale d’oggi. Vene cosi tolta di mezzo un’idea errata piuttosto diffusa: che lo yoga rappresenti uno stile di vita «esotico» sotto ogni punto di vista e che esso conduca perciò a una fuga dai valori occidentali e al rifugio in un modo di essere e di agire «diverso» perché orientale. Vedremo, al contrario, che i precetti morali dello yoga possono costituire il migliore bagaglio etico per un impegno attivane nella vita e nel contesto sociale di cui facciamo parte. Successivamente vengono esposte le pratiche igieniche riconducibili, insieme alle norme per una corretta alimentazione, al secondo stadio (niyama) dello hatha-yoga.
La seconda parte è tutta dedicata all’insegnamento delle tecniche; innanzitutto il rilassamento, quindi le posizioni (âsana) e il controllo del respiro (prânâyâma) che costituiscono tradizionalmente il terzo e quarto stadio dello hatha-yoga. In questa parte operativa ho inteso realizzare un insegnamento vivo davvero una «scuola di yoga» dove l’allievo viene guidato con dettagliate descrizioni, affiancate da disegni chiari ed essenziali, a rendersi padrone delle tecniche esposte: queste sono state suddivise in «livelli» di crescente difficoltà, per un apprendimento graduale che può scegliere tra diversi «percorsi» e divenire così individualizzato secondo il talento e le caratteristiche di ciascun allievo.
La terza parte è costituita da tavole fotografiche: queste saranno utili a chiarire eventuali dubbi e a perfezionare l’esecuzione degli âsana, data la maggiore ricchezza di dettagli rispetto ai disegni.
Nella quarta e ultima parte ci si accosta alla psicologia dello yoga. Dopo una breve introduzione teorica viene proposta una serie di esercizi di concentrazione e meditazione, che costituiscono i livelli superiori dello hathayoga (pratyâhâra, dhyâna, dhâranâ).
Mi auguro che tutti coloro i quali non hanno la possibilità di frequentare una scuola di hatha-yoga possano trarre un adeguato beneficio dall’uso di questo libro. Esso contiene tutte le informazioni e i suggerimenti che necessitano a un allievo per progredire in modo soddisfacente: il resto è lasciato alla serietà d’intenti e alla perseveranza con cui ciascuno vorrà dedicarsi alla pratica degli esercizi.
ALLA RICERCA DELLA PACE MENTALE
Il termine yoga trae la sua origine dalla radice sanscrita yuj, che significa «unire, legare insieme, aggiogare». Si tratta infatti di una disciplina il cui scopo consiste nel «legare insieme» le funzioni e le energie psico-fisiche dell’individuo sottraendole a quella dispersione cui sono sottoposte nella vita ordinaria.
È sufficiente un modesto grado di introspezione per renderci conto di come soprattutto la nostra vita psichica si svolga all’insegna della dispersione e della molteplicità. Senza tregua la nostra mente è attiva: ricordi, progetti, attese, emozioni positive e negative, gli stati mentali più eterogenei si avvicendano incessantemente. La vita stessa, con il quotidiano impegno che ci richiede, impone questo fervore tumultuoso, al quale però talvolta vorremmo sottrarci, sia pure per poco, così da ritrovare quell’io reale che alberga nel profondo in ciascuno di noi, colui che. pur nella molteplicità delle forme mentali, ne è l’imperturbato testimone, colui che «non agisce e non patisce macchia».
Se prendiamo in esame una qualunque giornata della nostra esistenza quotidiana ci rendiamo conto facilmente di come, ad esempio, è cangiante il nostro stato d’animo a seconda dei diversi rapporti umani che dobbiamo affrontare. Nel corso del tempo molti «io» differenti o addirittura opposti si susseguono l’uno all’altro: ora impersoniamo la dolcezza, ora predomina l’aggressività, ora l’entusiasmo ci prende la mano e ci sentiamo di affrontare e condurre in porto i compiti più gravosi. Ecco allora che il nostro io «è» entusiasmo, «è» fiducia, in un’identificazione totale con uno stato d’animo che sembra coinvolgere tutto il nostro essere. Ma all’improvviso si verifica una contrarietà, oppure un disturbo fisico, magari di poco conto, viene a importunarci: un repentino mutamento di umore e tutto a un tratto ci sentiamo depressi, sfiduciati, sicché ciò che poco prima ci sembrava semplice e facile appare ora irto di difficoltà insormontabili.
MASCHERE SOCIALI
Qualcuno potrebbe rifiutarsi di riconoscere se stesso in questa analisi, ritenendo di essere «tutto d’un pezzo». Certo non siamo tutti uguali: vi sono persone il cui animo è più mutevole, la cui emotività è più fragile, sicché la loro vita è come una di quelle giornate primaverili, caratterizzate dal tempo variabile, quando stormi di nubi corrono incessantemente attraverso il cielo e il sole appare e scompare ad ogni istante. Altre persone, quelle di cui si dice che «hanno carattere», sono meno soggette a questa variabilità di umore: ma sta di fatto che tutti, chi più chi meno, sperimentiamo quotidianamente l’influenza delle circostanze esterne sul nostro stato psico-fisico.
Anche colui che ha la rassicurante sensazione di essere tutto d’un pezzo si accorgerà, a un più attento esame, di possedere il suo bagaglio di «maschere»: maschere sociali, che indossa o dismette a seconda del ruolo che gli compete nei vari momenti della vita di tutti i giorni. Siamo forse gli stessi quando trattiamo con superiori o con sottoposti, con amici e familiari, oppure con estranei? Al contrario, il nostro atteggiamento muta e ci adeguiamo, in maniera più o meno conscia, alle esigenze dei diversi rapporti umani. Questa multiformità non è in sé un male: è anzi il presupposto di una vita sociale accettabile. Il vero pericolo è di non riuscire più a veder chiaro in noi stessi, confondendo, ad esempio, il nostro io reale con una delle maschere, magari con quella che ci imponiamo più sovente e con la quale ci siamo così identificati da non essere più capaci di riconoscerci quali realmente siamo.
Vediamo dunque che a tal punto siamo tutt’uno con la multiforme attività estroversa della nostra mente, sollecitata dalle necessità della vita pratica, che ci diviene impossibile, senza l’aiuto di una tecnica specifica, realizzare a comando la soppressione controllata degli stati mentali in vista di uno stato di coscienza superiore. Talvolta ci sforziamo di realizzare quel vuoto della mente che ci permetterebbe di cogliere il nostro io profondo, saldo in se stesso nella sfera dell’essere, sottratto al volubile gioco del divenire e del molteplice. La mente però si ribella alla forzata inattività che tentiamo di imporle, i pensieri che ci sforziamo di scacciare si fanno più insistenti, il corpo stesso diviene una presenza molesta: avvertiamo la tensione che vi alberga, necessaria forse per affrontare le piccole e grandi battaglie della vita quotidiana, ma di cui non riusciamo più a sbarazzarci quando vorremmo farne a meno.
Ci rendiamo conto, allora, di non essere veramente liberi. Anche se nessuna costrizione esterna ci condiziona, siamo tuttavia sottoposti all’inquieto tumulto delle nostre emozioni, al disordinato errare dei nostri pensieri, al gioco delle parti della vita di tutti i giorni, alle molestie che ci procura il nostro stesso corpo, sia quando «somatizziamo» ansie e tensioni, sia quando esso si ribella a uno stile di vita innaturale quale per lo più gli imponiamo.
COMPETITIVITÀ E CONSUMISMO
Alla naturale difficoltà che l’uomo ha trovato, in qualunque epoca della sua storia a farsi signore di se stesso, la moderna civiltà occidentale aggiunge le sollecitazioni di una cultura che troppo spesso punta all’esteriorità e all’appagamento dei sensi. Oggi, più che in qualsiasi periodo del passato, l’uomo si aspetta «dall’esterno» la soluzione dei problemi che lo angustiano La pubblicità di uno sconfinato numero di prodotti di consumo, fatti apposta per facilitare la fruizione edonistica dell’esistenza, ci bombarda con i suoi messaggi. Alla legittima aspirazione che l’umanità nutre per un adeguato livello di benessere, che la sollevi dalle pene di una vita tribolata, la moderna civiltà industriale aggiunge tutta una serie di falsi bisogni o addirittura meri «simboli di stato» alla cui lusinga l’uomo medio difficilmente riesce a sottrarsi.
Nasce così l’illusione di potersi comprare la felicità a patto di avere abbastanza denaro: ciò promuove un’esasperata competitività sociale dove il traguardo da tutti ambìto è il successo, non già inteso nel legittimo significato di realizzazione armonica di possibilità latenti, ma in quello riduttivo e mistificante di raggiungimento del massimo guadagno possibile. Questo stato di cose conduce l’uomo d’oggi a un inevitabile sentimento di frustrazione, sia perché, il più delle volte, considera insoddisfacente il suo «posto in classifica», sia soprattutto perché arriva prima o poi il momento in cui egli si interroga sulla validità di una scala di valori fondata sulla competitività sociale e sul possesso di beni materiali.
È legittimo ascrivere il costante aumento dei disturbi nervosi, sempre più dilaganti soprattutto nelle città industriali, non solo al senso di insicurezza che l’uomo prova ormai in ogni momento della sua esistenza, ma anche alla carenza di valori di questa stessa esistenza. Per un verso la sua dipendenza dall’esterno, da «altri» che non costituiscono più un prossimo, ma sono spesso entità anonime o addirittura minacciose, gli fa temere di poter essere abbandonato in balìa di se stesso; per altro verso, sebbene per sopravvivere sia forzato a rispettare le regole del gioco, egli finisce per avvertire talvolta con una chiara presa di coscienza, talvolta in modo subliminale che c’è qualcosa di fondamentalmente inautentico in una vita che ha per unica meta il guadagno e il prestigio esteriore. Non per nulla Jung, il padre della «psicologia analitica» affermava che la maggior parte dei suoi pazienti non soffrivano «di una specifica malattia, bensì del vuoto e della «mancanza di significato della propria vita».
Qualcuno potrebbe giudicare eccessiva questa critica radicale di certi «valori» della nostra civiltà occidentale e ritenere che sia dettata da nostalgie mistico-ascetiche. Per chi la pensasse così gioverà citare alcuni passi di un autore non certo sospetto di misticismo o irrazionalismo o di propendere a una visione «orientale» dell’esistenza. Mi riferisco a Konrad Lorenz, premio Nobel per i suoi studi sul comportamento animale, fondatore riconosciuto della moderna etologìa (=scienza del comportamento). è significativo come il punto di vista di questo uomo di scienza coincida con quello del seguace dello yoga e sia fortemente critico nei riguardi della moderna civiltà occidentale. Egli infatti scrive:
«Sorge spontaneo il quesito se all’anima dell’uomo odierno procuri maggiore danno l’accecante sete di denaro oppure la fretta logorante. Qualunque sia la risposta, coloro che detengono il potere, indipendentemente dall’orientamento politico, hanno interesse a favorire entrambi questi fattori e a ingigantire le motivazioni che spingono l’individuo alla competizione. Non mi risulta che esista finora una analisi psicologica profonda di queste motivazioni; ritengo tuttavia molto probabile che, oltre alla brama del possesso e all’ambizione di ottenere una posizione di rango più elevato, un ruolo molto importante sia svolto in entrambe dalla paura: paura di essere superati dai concorrenti, paura di diventare poveri, paura di prendere decisioni sbagliate e di non essere, o non essere più. all’altezza di una situazione estenuante».
È degno di nota come lo stesso Lorenz, poche righe più oltre, richiami l’attenzione del lettore sull’importanza dell’introspezione e della meditazione, sottolineando l’incapacità dell’uomo moderno di dedicarsi a esse attraverso la pratica del silenzio:
«Uno dei peggiori effetti della fretta, o forse dell’angoscia che ne è la causa diretta, è l’evidente incapacità degli uomini moderni di rimanere soli con se stessi, sia pure per breve tempo. Essi evitano con scrupolo ansioso qualsiasi possibilità di meditazione e d’introspezione; forse temono che la riflessione possa metterli di fronte a una agghiacciante immagine di se stessi, come quella descritta da Oscar Wilde nel suo classico romanzo dell’orrore // ritratto di Dorian Gray. Il dilagante bisogno di rumore, che sembra paradossale se si considera la nevrastenia degli uomini d’oggi, si spiega soltanto col bisogno di soffocare qualcosa».
Lo yoga ha l’ambizione di offrirsi come rimedio efficace per coloro che avvertono il disagio derivante da questa incapacità di ritornare al proprio centro (meditare = stare al centro). Esso infatti si presenta come una via di realizzazione che, avvalendosi di tecniche appropriate, conduce l’individuo al dominio della propria unità psicofisica attraverso un allenamento progressivo. «Anche poco di questo retto procedere», dice la Bhagavadgîtâ, «libera da grande paura». Con la cessazione della paura degli altri non ha più ragione di essere una esasperata competitività che avvelena i rapporti umani. Con la cessazione della paura di se stessi diviene possibile il silenzio interiore e il ritrovamento dell’autentico «sé».
L’AZIONE RIEQUILIBRATRICE DELLO HATHA-YOGA
Lo hatha-yoga agisce in profondità, sul corpo e sulla psiche, armonizzando ciò che è disarmonico, riportando equilibrio là dove questo è venuto meno: l’effetto di una pratica costante non è tanto una trasformazione della personalità quanto piuttosto l’integrazione e la maturazione delle potenzialità latenti che vi sono in ogni essere umano. L’allenamento, come si è detto, è graduale e progressivo: esso impegna lo yogin (= colui che pratica lo yoga) sul piano fisico, mentale e morale.
Di solito gli occidentali che si accostano per la prima volta allo yoga ritengono di avere a che fare con una semplice ginnastica, sia pure di un tipo particolare nata in India in un lontano passato con motivazioni mistico-religiose; una ben strana ginnastica, fatta di posture ieratiche e contorcimenti bizzarri, la quale tuttavia «funziona», producendo effetti salutari e vitalizzanti sicché può essere adattata ai fini utilitaristici del mondo occidentale d’oggi. Vi sono manuali di yoga che incoraggiano apertamente tale opinione e bandiscono quindi ogni riferimento alla componente filosofica e psicologica della disciplina, mentre ormai nei villaggi-vacanze di svariate località turistiche si impartiscono con disinvoltura lezioni di yoga accanto a quelle di tennis, surf a vela, o pesca subacquea. Molte palestre, parallelamente all’insegnamento delle arti marziali giapponesi, organizzano corsi di yoga e capita ancora di incontrare persone le quali ritengono che «yoga» e «judo» siano più o meno la stessa cosa. Si vedono nascere inoltre centri alla moda di «danza e yoga», destinati a signore con problemi di linea...
Tutto ciò contribuisce ad accrescere l’errata opinione che lo yoga, nella forma in cui può essere praticato dall’occidentale medio, si riduca a un’attività puramente fisica che consiste nell’assumere e mantenere determinate posizioni corporee. In verità lo hatha-yoga attribuisce una grande importanza al corpo: molte tecniche hanno lo scopo di conseguire una perfetta padronanza delle funzioni fisiche. Nessuno invero più di uno yogin considera il corpo come tempio dello spirito e al tempo stesso come docile strumento dell’io superiore. Come un violinista, attraverso anni di indefesso esercizio perviene al pieno dominio del suo strumento, sicché nessun virtuosismo, per quanto ardito, gli è precluso, così lo yogin acquista padronanza del suo corpo perfetto, che irradia armonia, vitalità e vigore.
Secondo lo yoga, infatti, non vi può essere alcun reale progresso sul piano spirituale finché il corpo costituisce un molesto fardello ed è soggetto a disturbi che compromettono l’armonia dell’unità psicofisica. Purtroppo la civiltà moderna non è la migliore alleata della nostra salute, non ostante i continui progressi della scienza medica. A questa infatti si chiede il miracolo quando anni e anni di errori hanno causato guasti irrimediabili: basta guardarsi attorno per osservare un’umanità spesso dolente, che paga in termini di sofferenza fisica e morale l’allontanamento da un regime di vita conforme alla natura. È il risvolto negativo che reca con sé l’accresciuto confort della nostra esistenza; mentre quasi i due terzi della popolazione mondiale vivono tuttora in uno stato di sottoalimentazione, nella nostra civiltà opulenta ci si ammala per eccesso di cibo; inoltre la maggior parte delle persone è ormai disavvezza a una sana, seppur faticosa, attività fisica, qual era, ad esempio, quella della civiltà rurale contadina.
Il ritorno alla natura: quante volte questo mito è ricorso nella storia dell’umanità! Ebbene, esso costituisce per lo hatha-yoga un imperativo categorico: alimentazione, respirazione, igiene personale, posture, hanno il fine di restituire al corpo l’armonia di funzioni che gli compete. Serenità di spinto, energia e vitalità, sono il premio che lo yoga offre alla nostra perseveranza, purché si ritorni a vivere secondo i dettami della natura.
QUANTO OCCORRE IMPEGNARSI?
Alcuni manuali di yoga, scritti da autori occidentali, insistono sul fatto che è possibile ottenere grandi risultati con un impegno personale molto ridotto «Dateci quindici minuti al giorno e faremo di voi dei perfetti yogin!»: questo potrebbe essere lo slogan di certe pubblicazioni. In realtà le cose non stanno proprio così: una seria pratica dello hatha-yoga, sia pure adattata alle possibilità medie dell’uomo occidentale, comporta, indipendentemente dal fattore tempo, un coinvolgimento globale della personalità. Tale pratica non può essere un’attività episodica inserita alla meno peggio nella nostra giornata fitta di impegni, come avviene per uno sport qualunque, ma significa innanzitutto una scelta esistenziale. Chi affronta lo yoga, in altre parole, si mette su una via che implica in una certa misura l’accettazione di una determinata visione del mondo, la quale è nel contempo una gnosi e un’etica.
In questa prospettiva perde di significato la domanda: «Quanto tempo dobbiamo dedicare allo yoga?». Poiché lo yoga, come vedremo, comporta un nuovo modo di respirare, di nutrirsi, di lavorare, di considerare i rapporti interpersonali, perfino di riposare; poiché si fonda su di una morale cui occorre offrire viva testimonianza nelle contingenze della vita pratica, esso finisce per investire di sé e riplasmare l’intera esistenza. Se invece la domanda di cui sopra si riferisce in senso stretto agli esercizi (posizioni e tecniche respiratorie) si potrà calcolare un impegno giornaliero da un’ora a un’ora e mezza comprensivo di due sedute: una principale al mattino e una più breve nel tardo pomeriggio o alla sera.
GLI OTTO STADI DELLO HATHA-YOGA
Si è detto che lo hatha-yoga comporta un allenamento progressivo che esige una pratica costante. Non per nulla alla radice da cui deriva il termine «yoga» si può fare risalire la parola «giogo»: praticare lo hatha-yoga significa anche «aggiogarsi», cioè sottomettersi volontariamente a una disciplina che, se da un lato bandisce ogni violenza, anche su se stessi, richiede tuttavia l’impegno di uno sforzo graduale e perseverante. è questo precisamente il significato della parola hatha, la quale si può tradurre sia «forza» sia «perseveranza»: «hatha-yoga» vuol quindi significare «unione (cioè integrazione delle facoltà e delle energie psicofisiche) per mezzo di una forza perseverante (= uno sforzo progressivo)».
La pratica dello hatha-yoga si pratica attraverso otto stadi, di cui i primi quattro appartengono alla sfera fisica, mentre i successivi riguardano invece la sfera psichica. Essi sono:
1) yama o «astinenze»: questo primo stadio costituisce la base morale della disciplina ed è il presupposto necessario per un reale progresso negli stadi successivi.
2) Niyama o «osservanze»: comprende precetti di purificazione, norme igieniche, nonché precetti sul corretto atteggiamento mentale dell’aspirante yogin. Questi infatti deve possedere letizia (samtosa), autodisciplina (tapas) e volontà di migliorarsi attraverso l’autoeducazione (svâdhyâya).
3) Âsana o «posizioni»: insieme allo stadio successivo gli âsana costituiscono la chiave di volta dello hatha-yoga.
4) Prânâyâma o «tecniche di controllo della forza vitale» (prâna) attraverso esercizi respiratori.
5) Pratyâhâra, o «ritrazione della mente» dagli oggetti sensibili.
6) Dhâranâ, o «concezione mentale» su un solo oggetto.
7) Dhyâna o «meditazione». Le tecniche di questo stadio sono state fatte proprie anche dal Buddismo e, dopo essere passate in Cina sotto il nome Ch’an si sono estese al Giappone dando origine allo zen.
8) Samâdhi,o anche «en-stasi mistica»: è questo lo stadio supremo, accessibile a pochi adepti, nel quale la dimensione umana viene trascesa e si attinge l’Assoluto.
È importante sottolineare che questi otto stadi o «membra» (anga) dello hatha-yoga non devono essere intesi come tappe rigorosamente separate le une dalle altre, quasi altri compartimenti stagni; al contrario, la pratica dello yoga è piuttosto un apprendimento ciclico, con ritorni e approfondimenti successivi. Ad esempio, l’accettazione di una base etica è il promo passo che viene richiesto al neofita per poter progredire negli stadi più avanzati: al tempo stesso la profonda azione riequilibratrice delle posizioni e delle tecniche respiratorie favorisce nello yogin una più autentica adesione alle norme morali, che vengono così integrate nello sforzo del suo modo di essere e di vivere.
VI SONO CONTROINDICAZIONI?
In linea generale non vi sono controindicazioni alla pratica dello hatha-yoga nel suo insieme: poiché esso genera un’azione riequilibratrice molto disturbi possono trarre un notevole beneficio da un uso appropriato degli esercizi. Bisogna ricordare però che lo yoga non è una panacea universale e il suo scopo nontanto quello di guarire chi è malato quanto quello di mantenere in buona salute chi è sano. Sarebbe quindi un grave errore accostarsi allo hatha-yoga aspettandosi dalle sue tecniche guarigioni miracolose di stati morbosi cronici o di lesioni irreversibili. Ci possono essere quindi delle situazioni in cui si impongono buon senso e prudenza, soprattutto nell’affrontare le tecniche pi impegnative. Più oltre, quando verrà trattata la tecnica delle singole posizioni, saranno anche specificate le eventuali controindicazioni e le cautele da adottare in caso di malattia: nel dubbio comunque è sempre consigliabile consultarsi con il proprio medico, il quale potrà aiutarci a fare un bilancio della situazione. L’ideale sarebbe avere un medico con nozioni di yoga, in grado di indicarci i nostri «punti» deboli sui quali l’allenamento può efficacemente intervenire come correttivo.
HATHA-YOGA PER GIOVANISSIMI
Per quanto riguarda il fattore età sembra esserci tra i divulgatori occidentali dello yoga una notevole disparità di opinioni. Alcuni infatti incoraggiano la pratica delle tecniche dello hatha-yoga fin dall’età prescolare; altri invece sostengono che un bambino, anche se impara meccanicamente l’esecuzione delle posture, non è in grado di comprenderne lo spirito e quindi non trae un reale beneficio dagli esercizi.
In entrambi questi punti di vista c’è qualcosa di vero. In apparenza quelli che sconsigliano lo yoga nell’età infantile sembrerebbero avere argomenti inoppugnabili, come quando sostengono che solo con la cosiddetta «età» della ragione un individuo diventa capace di scegliere liberamente e in piena coscienza una via di autodisciplina e di autorealizzazione quale è appunto la pratica dello hatha-yoga. Sembra inoltre che una forma di educazione fisica basata in buona parte sull’immobilità come gli âsana, sia poco adatta ad un’età che ha bisogno del gioco, Inteso come movimento, salto, corsa, lotta: attività attraverso le quali il bambino, non diversamente da tutti i cuccioli, prende coscienza dei proprio corpo e impara a coordinarne sempre meglio le funzioni psicomotorie.
In realtà nulla vieta che vengano inseriti in un programma di educazione fisica per giovanissimi anche esercizi derivati, con opportuni adattamenti, dalle tecniche yoga, in particolare quelle che favoriscono l’acquisizione di un buon equilibrio statico e dinamico. Ad esempio posizioni come «l’albero» in cui si tratta di saper stare ben diritti su una sola gamba, possono essere lo spunto per un gioco di gruppo. L’importante è che non venga meno la caratteristica di attività ludica che l’educazione fisica deve possedere quando è ai bambini in età prescolare. Alla fantasia di un istruttore che abbia qualche pratica di hatha-yoga non sfuggirà la possibilità di inventare tutta una serie di giochi derivati dagli âsana: già i nomi stessi delle posizioni, che ricordano animali cari al mondo infantile (la cavalletta, il coniglio, il cammello, ecc.), dovrebbero far buona presa sull’interesse dei bambino favorendo la sua attiva partecipazione.
Per l’educazione fisica dei preadolescenti potranno invece essere utilizzate altre posizioni che sono particolarmente indicate come preparazione alla pratica sportiva. Molti âsana, come vedremo, agiscono attivamente su masse muscolari, come i dorsali e gli addominali, che normalmente non vengono abbastanza esercitate, sicché tendono a indebolirsi: tenere in esercizio questi muscoli fin dall’infanzia può essere assai raccomandabile.
La maggior parte delle posizioni funziona poi egregiamente come ginnastica correttiva: molto spesso i giovani, anche a causa delle lunghe ore di studio, tendono ad assumere atteggiamenti corporei malsani, cioè i cosiddetti paramorfismi. Questi consistono soprattutto in deviazioni leggere e temporanee della spina dorsale che però, se non vengono corrette per tempo, si trasformano nei ben più gravi dismorfismi, ai quali è molto più difficile, se non impossibile, porre rimedio. L’azione degli âsana è efficace soprattutto sulla colonna vertebrale, perciò con la pratica delle posture è facile ovviare ai paramorfismi, abituando il giovane a un portamento corretto.
Le posizioni sedute, o «di meditazione» saranno invece meno indicate, dato il loro carattere di assoluta immobilità, per bambini e ragazzi. C’è da notare tuttavia che, mentre a un adulto non allenato possono occorrere settimane o mesi prima di «sciogliersi» al punto da poter eseguire facilmente posizioni come il «loto», a un fanciullo sano riesce agevole assumere tale postura, poiché le sue articolazioni sono molto più elastiche. È quindi raccomandabile che anche i giovanissimi pratichino di tanto in tanto questo tipo di esercizi, atti a prevenire l’irrigidimento e l’anchilosi di anche, ginocchia e caviglie.
E PER NON PIÙ GIOVANISSIMI
Le persone che hanno raggiunto o superato la mezza età e che da tempo hanno rinunciato a tenersi in forma con la pratica di qualche sport o di una qualsiasi attività fisica possono essere indotte a considerare troppo impegnative per loro le tecniche dello hatha-yoga. Rinunciare in partenza sarebbe però un grave errore: infatti proprio chi fa vita sedentaria, spesso congiunta a un lavoro stressante e ad abitudini alimentari malsane, può ricavare il massimo beneficio dagli esercizi.
Un punto, del resto, merita di essere chiaramente sottolineato: a nessuno si richiedono prestazioni di tipo atletico. La via dello hatha-yoga comporta un dosaggio progressivo degli sforzi; la prima regola da osservare, come vedremo, è quella della non-violenza, e innanzitutto occorre imparare a non fare violenza a se stessi. Niente sforzi inauditi, dunque, niente acrobatismi, che lasceremo ai virtuosi della pratica: a noi basterà la progressiva riconquista, attraverso un allenamento perseverante, di quella scioltezza e armonia di movimenti e di quel giusto grado di vigorìa fisica che chiunque, a qualunque età, può conseguire.
Fino a che punto lo hatha-yoga può mantenerci giovani? L’età, si dice, è in gran parte una questione di spirito e sappiamo che lo yoga, oltre a prendersi cura dei nostri muscoli e delle nostre articolazioni, ci assicura la giusta «carica» di vitalità, grazie anche all’azione che molte posizioni esercitano sulle nostre ghiandole endocrine. Tuttavia, come non è una panacea universale, pur avendo parecchie utili indicazioni, così lo hatha-yoga non è neppure la fonte dell’eterna giovinezza. Accostarsi a esso con il desiderio ossessivo di mantenersi giovani a tutti i costi significa snaturarne lo spirito e le finalità. Il tempo che ci è dato possiamo soltanto usarlo, non fermarlo: lo yoga ci aiuta ad usarlo bene, realizzando il massimo delle nostre potenzialità; ma se è vero che esso ci promette armonia e integrazione della personalità, non dimentichiamo che ci impone anche di rinunciare a ogni eccessivo attaccamento. Accettiamo quindi con gioia i doni che ci può dare, senza coltivare la segreta speranza di far camminare a ritroso l’orologio della vita. Correttamente praticato lo yoga può contribuire a una maggiore longevità, ma soprattutto può aiutarci ad accogliere con serenità e a vivere con pienezza ogni stagione della nostra esistenza, senza vagheggiamenti e rimpianti, sapendo di essere, in ogni istante, signori di noi stessi.
YOGA E FEDE RELIGIOSA PERSONALE
Accade talvolta di incontrare persone fermamente convinte che praticare lo yoga voglia dire accettare un credo religioso incompatibile con una visione cristiana dell’esistenza. In verità nessuno degli otto stadi dello hathayoga è in contrasto con la fede o con la morale cristiana: se alla base del messaggio evangelico troviamo come fondamentale precetto l’amore del prossimo, alla base dell’etica yoga vi è l’ahimsâ o non-violenza, che è amore del prossimo, cioè dell’uomo, ma anche, francescanamente, di tutte le creature.
Le tecniche dello hatha-yoga, poi, non sono che strumenti e il loro uso non presuppone l’appartenenza a questa o quella fede religiosa. Praticare lo yoga non vuoi dire che si debba diventare indù: in ogni caso anche chi volesse andare oltre una mera «utilizzazione» delle tecniche e approfondire, ad esempio, la lettura dei testi filosofici e religiosi che la tradizione indiana ci offre, potrà trovarvi tesori di spiritualità senza per questo dover rinunciare alla propria fede religiosa.
Come strumento di realizzazione lo hatha-yoga si presta a essere usato da chiunque, indipendentemente da ogni convincimento religioso: mantenersi in efficienza e buona salute, conservare vigile e pronta la propria mente, sembra un compito degno per un uomo che aspiri a dare nella vita il meglio di sé; a qualunque religione appartenga un tale uomo, egli sa di agire bene, glorificando il corpo che gli è stato dato. Che egli sia indù, cristiano o musulmano, non ha davvero molta importanza: ciò che conta è che sappia rendersi immune dal fanatismo di parte rispettando anche il credo altrui.
Lo yoga che viene insegnato in questo libro, è, come si è detto, soprattutto lo hatha-yoga cioè quello yoga che si cura principalmente del corpo e della mente, avvalendosi di tecniche psicofisiche, in particolare posizioni corporee ed esercizi di controllo del respiro. Lo hatha-yoga, sebbene in occidente si tenda a identificarlo tout court con lo yoga, è in verità soltanto una delle possibili vie che lo yoga, come filosofia e visione del mondo, propone all’uomo per superare lo stato ordinario di esistenza in vista di una realizzazione superiore. Queste diverse vie (mârga) non devono però essere intese come strade divergenti. Esse non si escludono a vicenda ma si integrano: perciò chi si dedica allo hatha-yoga può e in una certa misura deve conoscere le altre forme di yoga.
Tralasciando i rami secondari, che qui non ci interessano e che si fondano su tecniche particolari, limitiamocia qualche notizia sulle principali vie di realizzazione. Esse sono:
- jñana-yoga o «yoga della conoscenza»
- karma-yoga o «yoga dell’azione»
- bhakti-yoga o «yoga della devozione»
- râja-yoga o «yoga regale»
JÑÂNA-YOGA O «YOGA DELLA CONOSCENZA»
Questo yoga è la strada filosofica per eccellenza: jñâna infatti significa conoscenza. Si tratta quindi di una gnosi, una visione del mondo in cui trovano risposta le domande che l’uomo si pone su se stesso, sulla propria natura e sullo scopo dell’esistenza. Attraverso la conoscenza l’uomo deve saper scorgere il reale oltre le apparenze fenomeniche. Ogni essere umano, ad esempio, tende a identificarsi con il corpo fisico; ma per lo jñâna-yoga questo non è che la manifestazione più grossolana, al di là della quale vi è il «corpo sottile» o «prânico». Neppure questo però costituisce la natura reale dell’uomo, che è data dal suo âtman, cioè il vero Sé, principio immortale e divino che sta al di là dell’apparenza e della caducità della forma mortale. Nell’esistenza ordinaria l’uomo non riesce ad acquistare piena consapevolezza di questa realtà suprema e immutabile che egli alberga dentro di sé, poiché è soggetto all’inganno della mâyâ, o illusione cosmica, cioè l’apparenza fenomenica che lo disorienta con il suo perenne mutare. Soltanto affinando la sua capacità di discriminazione (viveka), rinunciando agli oggetti terreni, meditando sulla dottrina rivelata e sugli insegnamenti dei proprio maestro spirituale, il seguace dello jñâna si rende capace, mediante l’intelletto superiore (buddhi), di superare il fenomenico e conseguire il sommo bene.
KARMA-YOGA O «YOGA DELL’AZIONE»
È la via di realizzazione per mezzo delle opere, che devono essere compiute senza attaccamento alcuno e senza desiderio di successo.
I concetti fondamentali di questo yoga sono espressi mirabilmente nella Bhagavadgîtâ o «Canto del beato», poemetto filosofico di appena settecento versi inserito nel ben più vasto contesto del poema epico Mahâbhârata.
A buon diritto la Bhagavadgîtâ è stata ed è considerata un’opera di altissimo valore spirituale: molte personalità eccezionali, tra cui lo stesso Gandhi, ne hanno tratto ispirazione per la propria vita. L’inizio è drammatico: sul campo di Kuruksetra, dove le opposte schiere dei Pândava e dei Kaurava stanno per affrontarsi in battaglia, l’eroe Arjuna, al cui fianco in veste d’auriga è il dio Krsna, è colto da una crisi di sconforto. Benché prode guerriero, egli si rifiuta di impugnare le armi: al solo pensiero di uccidere i suoi stessi parenti, i Kaurava, un fremito d’orrore lo pervade tutto, ed è pronto a venir meno al suo dovere di guerriero, che gli imporrebbe di combattere per ripristinare l’ordine e la giustizia. I suoi avversari, infatti, sostengono il malvagio usurpatore Duryodhana: Arjuna dunque, combattendo e vincendo, compirebbe un’azione meritoria degna di un guerriero onorato.
L’appello all’onore militare non basta però a smuovere Arjuna dal suo proposito e a spingerlo a versare sangue fraterno: Krsna gli insegna allora una più profonda verità Soltanto i corpi - così dice il dio - sono mortali, mentre il Sé, l’âtman è imperituro: compia dunque Arjuna il dovere che gli compete, non rinunci all’azione, ma apprenda ad agire con distacco, senza attaccamento al frutto che dall’azione consegua o non consegua. La vera libertà non consiste nel non operare: del resto chi potrebbe, sia pure per un solo istante, astenersi dall’agire? Il segreto della libertà e della superiore realizzazione dell’uomo consiste nel retto atteggiamento dell’animo nel riguardi dell’azione (karman). È necessario dismettere ogni egoistico sentimento, ogni ansiosa attesa dei risultato: in questo modo l’azione, priva di attaccamento, priva di desiderio, diviene pura.
Chi pratica lo hatha-yoga dovrà far suo il più possibile questo ideale di distacco, pur nell’impegno quotidiano e di fronte alle continue difficili scelte che la vita ci impone. Il karma-yoga ci insegna che tutti abbiamo il dovere di portare nel mondo il contributo della nostra opera, ma al tempo stesso dobbiamo saperci affrancare dall’ansiosa attesa del risultato e del successo. è errato credere che lo yogin rifugga dalle proprie responsabilità, che gli derivano dal contesto sociale in cui vive: egli se le assume anzi fino in fondo, pienamente e consapevolmente, senza però lasciarsi coinvolgere sul piano emotivo.
Il detto «non vincere, ma gareggiare è importante» può ben essere fatto proprio dal karma-yoga: ciò non vuol dire che si debba rinunciare a ogni forma di competitività, la quale è anzi alla base di un certo progresso sociale. L’umanità occidentale, però, deve saper prendere le distanze da una certa competitività esasperata che finisce per essere causa di turbe emotive. Le nostre azioni sono per lo più così intensamente finalizzate al risultato da divenire motivo di attese angosciose. Supererò l’esame? Otterrà quel posto? Avrò impiegato bene il mio denaro? Impariamo invece a guardare alle nostre azioni come testimoni disinteressati per i quali successo e insuccesso si equivalgono. Qualche volta, ripensando a distanza di tempo alle speranze e ai timori che riponemmo un giorno in questa o quella nostra opera, ci viene fatto di sorridere. Era davvero così importante quel risultato? Forse poteva in parte mutare il corso esteriore della nostra vita, ma il nostro «io» reale ne sarebbe stato anch’esso mutato?
Alleniamoci dunque a conquistare quel distacco dal frutto delle opere che conduce alla serenità e alla perfetta letizia. La stessa pratica dello hatha-yoga deve essere riguardata con questo atteggiamento di indifferenza emotiva. Guai se le sedute quotidiane dovessero diventare fonte di ansiose aspettative! Ma su questo punto occorrerà ritornare quando parleremo dell’atteggiamento mentale da tenersi durante la pratica degli esercizi.
BHAKTI-YOGA O «YOGA DELLA DEVOZIONE»
Bhakti significa devozione: è questa dunque la via mistica per eccellenza, quella dell’abbandono fiducioso alla divinità. Come lo jñâna-yoga è la via della ragione, così il bhakti-yoga è la via dei cuore. In colui che segue questo sentiero le alte speculazioni dei filosofo cedono il passo a un irrefrenabile sentimento d’amore per il Creatore e la Sua manifestazione.
In occidente San Francesco, Santa Chiara, Jacopone da Todi, furono seguaci della vita della bhakti. In essa c’è una fede profonda che non ha bisogno di prove o dimostrazioni razionali. Il bhakta, o devoto, sa scorgere Dio dovunque, in ogni creatura animata e Inanimata: spesso il suo traboccante sentimento d’amore per il Divino si esprime in forma poetica, inni o laudi.
A differenza del karma-yoga la via devozionale comporta sovente una totale rinuncia al mondo: per chi è tutto assorbito dal Divino che senso hanno i legami sociali e i doveri terreni? Per colui che ha l’occhio fisso alla meta suprema le mete particolari, finite, perdono ogni attrattiva.
È evidente che una via come il bhakti-yoga richiede una vocazione religiosa non comune e una tendenza al misticismo piuttosto insolita nell’uomo d’oggi e che, quando si manifesta, non è esente da pericoli, in particolare per i giovani. Vi sono infatti sette religiose che tendono a sfruttare il bisogno di assoluto e di divino proprio soprattutto delle giovani generazioni: assistiamo così a forme degradate di adorazione devozionale rivolta a maestri, o guru, di dubbia fama e allo scimiottamento di forme di culto orientaleggianti.
Chi intende dedicarsi allo hatha-yoga avrà cura di evitare ogni forma di pseudomisticismo: del resto la sua pratica è perfettamente compatibile con qualunque fede religiosa e il credente non avrà bisogno di spogliarsi delle proprie tradizioni per rivolgersi a forme di culto «esotiche». Tuttavia tra gli esercizi di meditazione che troverete nella parte quarta di questo libro alcuni sono particolamente indicati per coloro che sentono il richiamo del Divino: ma anche chi per natura è eccessivamente portato al razionalismo non dovrebbe temere di aprire alla bhakti una parte di sé, dando spazio alle «ragioni del cuore» accanto a quelle dell’intelletto.
La divinità per il credente, la natura intesa come un tutto unico e armonico per il non credente, possono diventare oggetto di meditazione e di amore, e aiutare, di pari passo con gli esercizi dello hatha-yoga, a formare una personalità completa, serena ed equilibrata, nella quale, accanto alla ragione, anche il sentimento abbia il posto che gli compete.
RÂJA-YOGA O «YOGA REGALE»
Costituisce in certo qual modo il coronamento dello hatha-yoga, del quale riprende e approfondisce gli stadi superiori. Dice Vivekânanda: «Vi sono nella natura manifestazioni più dense e materiali ed altre manifestazioni che sono più sottili. Queste ultime sono le cause, le prime ne sono gli effetti. I fenomeni grossolani possono essere facilmente percepiti dai sensi, non ugualmente i sottili. La pratica del râja-yoga ci conduce appunto a renderci capaci di captare le percezioni sottili».
Tra le diverse vie di realizzazione il râja-yoga è quella che maggiormente si ricollega allo yoga classico (codificato da Patañjali negli Yogasûtra o «aforismi sullo yoga»), il cui scopo è la soppressione dell’attività mentale ordinaria e il conseguimento del samâdhi, vale a dire lo stato di en-stasi in cui ogni dualità di soggetto e di oggetto cessa di esistere. Nel râja-yoga le posizioni corporee (âsana) non hanno l’importanza che assumono nello hatha-yoga; il râja-yoga infatti le prende in considerazione solo in quanto si tratta di posture adatte alla pratica degli esercizi respiratori e delle tecniche di meditazione che consentono l’accesso a uno stato di coscienza superiore.
Si ricollega in parte al râja-yoga e in parte allo hatha-yoga il cosiddetto kundalinî-yoga: si tratta di una via di realizzazione che si avvale di tecniche psicofisiche finalizzate al risveglio dell’energia latente, denominata kundalinî o «l’avvolta», che si ritiene situata, come un serpente arrotolato nelle sue spire, alla base della colonna vertebrale. Nell’adepto del kundalinî-yoga questa energia, riconducibile evidentemente alla sfera sessuale, viene risvegliata con appropriate tecniche, soprattutto con particolari prânâyâma, e prende a salire attraverso i vari centri del corpo sottile, denominati cakra (corrispondenti grossomodo ai plessi della fisiologia occidentale), fino a raggiungere il cakra più elevato, detto «loto dai mille petali», posto alla sommità del capo: quando ciò avviene si ha l’illuminazione.
È appena il caso di sottolineare che pratiche di questo genere appartengono allo yoga esoterico ed esigono la guida di un esperto maestro. Si tratta infatti di tecniche in cui sono insiti vari pericoli: è perciò del tutto sconsigliabile tentare da soli queste esperienze, a rischio di gravi e irreversibili disturbi.
Yama: le norme morali dello yoga
Come si è detto la pratica dello hatha-yoga si svolge attraverso otto stadi (ashta-anga), di cui i primi quattro costituiscono lo «stadio esteriore», in quanto si occupano soprattutto del corpo, mentre i quattro successivi costituiscono lo «stadio inferiore» in cui prevalgono gli esercizi di concentrazione e meditazione. Il primo stadio, o yama, comprende una serie di prescrizioni morali la cui osservanza è ritenuta indispensabile per un reale progresso nello hatha-yoga. In particolare vengono raccomandate:
1) ahimsâ, o «non-violenza»
2) satya, o «sincerità»
3) asteya, o «onestà»
4) brahmacarya, o «continenza»
5) aparigraha, o «astensione dal possesso»
Sono compatibili queste prescrizioni tradizionali con le esigenze della moderna vita occidentale? In verità si tratta di norme morali che, rettamente intese e applicate senza ipocrisia o inutili formalismi, dovrebbero fare parte del bagaglio morale di ogni essere umano il quale aspiri a migliorare se stesso, per mezzo dello yoga o di altre vie, in armonia con la natura e il consorzio civile di cui è membro. Chi si accinge alla pratica dello hatha-yoga dovrà quindi fare un preliminare esame di coscienza riguardo alle «cinque astinenze». Passiamole brevemente in rassegna una per una:
AHIMSÂ O «NON VIOLENZA»
«Non-violenza» è oggi un’espressione di gran moda: eppure mai come ai giorni nostri il mondo sembra essere dominato dalla violenza. Tra le innumerevoli specie di esseri viventi che popolano la terra, nessuno come l’uomo ha posto il suo talento al servizio dell’aggressione e della distruzione dei suoi simili. In un mondo in cui la violenza sembra crescere di giorno in giorno a dismisura, spesso ammantata di coperture e giustificazioni ideologiche, il seguace dello hatha-yoga ha il dovere di portare un preciso contributo alla causa della non-violenza: egli opererà dunque in ogni circostanza, con parole e azioni, in favore della pace, della distensione e dell’armonia. Purtroppo le buone intenzioni non bastano: spesso anche nell’essere umano in apparenza più mite e tollerante riemergono pulsioni profonde che si traducono in atteggiamenti aggressivi. Non sempre la violenza si manifesta con azioni concrete: un atteggiamento altezzoso, una studiata maldicenza, un’astiosa indifferenza... quanti modi di ferire gli altri!
La costante pratica degli esercizi dello hatha-yoga, in particolare le tecniche di rilassamento e il controllo della respirazione, contribuirà progressivamente a smorzare le tensioni emotive, e quindi anche la pulsione aggressiva che è presente in ciascuno di noi. Occorre tuttavia aiutare questo processo inconscio di trasformazione meditando sul profondo valore morale di una scelta non-violenta. Uno degli assiomi dello yoga è che ogni azione buona o cattiva che sia, produce dei frutti, i quali prima o poi vengono a ricadere su colui che ha compiuto l’azione stessa: la scelta dell’ahimsâ è quindi la giusta via per diffondere armonia e pace ed esserne ripagati.
La non-violenza deve riguardare non solo il mondo esterno, cioè il nostro prossimo, ma anche noi stessi: ecco dunque che lo hatha-yoga bandisce ogni sforzo violento, cui sostituisce un’applicazione graduale e costante. In questo modo, nella pratica concreta delle tecniche yoga, l’ahimsâ cessa di essere un concetto astratto, e viene vissuta tangibilmente nelle fibre del nostro essere fisico e mentale.
Fare dell’ahimsâ oggetto di meditazione, sforzarsi di realizzarne l’ideale nella vita quotidiana, può portarci a un progresso spirituale immenso. Alla non-violenza va congiunto l’abbandono di ogni atteggiamento di arrogante presunzione e la conquista di una sana umiltà. Per troppo tempo larga parte dell’umanità ha confuso l’indiscussa superiorità intellettuale dell’uomo con il diritto al dominio e allo sfruttamento, senza alcuna limitazione morale, delle molteplici forme di vita che popolano la terra: la non-violenza, al contrario, comporta un profondo rispetto per tutti i viventi, uniti in un unico multiforme disegno.
Qui sorge immediatamente un problema: deve lo yogin essere vegetariano, in armonia con il principio del rispetto della vita? In realtà, lasciando da parte per il momento ogni considerazione dietetica, c’è da dire che la rinuncia al cibo carneo non elimina del tutto la violenza ai viventi. Nel momento in cui strappo dalla terra un cespo di insalata per imbandirne la mia mensa vegetariana non uccido forse un essere vivente, privando la pianticella del suo divenire? È inevitabile che il vivente divori il vivente: la tigre che squarcia la gola dell’antilope e si nutre delle sue viscere ancora palpitanti non è più «feroce» della placida vacca, la quale «uccide» a ogni pasto migliaia di teneri steli. La verità è che non esistono animali «feroci», come non esistono animali «nocivi»; l’unico animale che ha dato prova di essere a un tempo feroce e nocivo è l’uomo! Esso infatti è l’unico essere vivente che si accanisce per crudele divertimento, desiderio di guadagno, o pura stupidità, a uccidere altri esseri viventi e i suoi stessi simili.
Lo yogin potrà dunque accettare o rifiutare, secondo le sue intime convinzioni, l’uccisione di animali per esigenze alimentari, ma il principio dell’ahimsâ gli farà ripudiare qualsiasi forma di «sport» o attività, come la caccia, il tiro al piccione, ecc., che provochino sofferenze e morte ad altri esseri viventi. Per quanto concerne la violenza dell’uomo sull’uomo, così diffusa in forme evidenti e occulte, è chiaro che il seguace dello yoga manifesterà in ogni occasione, con fermezza e coraggio, senza compromessi, la sua condanna per ogni sopraffazione materiale e morale perpetrata da individui o regimi su altri esseri umani.
SATYA O «SINCERITÀ»
La seconda prescrizione morale che lo yogin è tenuto a rispettare è l’astensione da qualsiasi forma di menzogna o di ipocrisia, le quali devono essere bandite in ogni circostanza dalle sue parole e dalle sue azioni. Occorre naturalmente guardarsi dal formalismo, che diverrebbe a sua volta una forma di ipocrisia: le piccole esigenze quotidiane della vita pratica possono costringerci a qualche peccato veniale. Del resto la verità, espressa impietosamente, in forma brutale, può diventare una vera e propria forma di violenza, contravvenendo al precetto dell’ahimsâ.
Ci sono poi dei casi In cui la bugia cosiddetta «pietosa» si impone: chi oserebbe gettare in faccia la verità sul suo stato a un malato cosi grave che potrebbe restare ucciso da una forte emozione?
Il precetto della sincerità impone al seguace dello hatha-yoga di rifuggire da ogni forma di mistificazione: ciò significa scegliere la via di realizzazione delle tecniche yoga con il desiderio sincero di migliorare se stessi, con umiltà e impegno, senza trionfalismi ed esibizionismi. Lo hatha-yoga esclude tassativamente ogni millanteria: i progressi compiuti ben possono rallegrarci, ma occorre evitare di parlarne a destra e a manca per suscitare interesse o ammirazione. è il nostro modo di essere, non le parole, che deve testimoniare la verità, cioè l’autenticità dei paziente lavoro che giorno per giorno, con l’ausilio dello yoga, compiamo su noi stessi.
ASTEYA O «ONESTÀ»
È appena Il caso di soffermarsi su questa prescrizione morale che si ricollega strettamente alla precedente: è evidente che non ci può essere una reale crescita armonica della personalità se non conformandosi a un ideale di onestà assoluta. Un comportamento disonesto contraddice infatti al principio della sincerità: nel contempo, provocando in modo deliberato un danno al nostro prossimo, viene a costituire una vera e propria forma di violenza, in contrasto quindi con il precetto dell’ahimsâ.
Oltre che con il prossimo, lo hatha-yoga comporta l’obbligo di essere onesti anche con se stessi. Quante volte, nella vita, ci autoinganniamo, come quando rimandiamo di giorno in giorno la realizzazione di un buon proponimento che ci costa sacrificio, oppure chiudiamo gli occhi sui nostri difetti! è quindi importante, se vogliamo davvero progredire, saper essere obiettivi e imparziali nel giudicarci.
BRAHMACARYA O «CONTINENZA»
In tema di continenza sembra esservi una grande disparità di opinioni tra gli autori di libri sullo yoga destinati agli occidentali. Alcuni infatti raccomandano un severo controllo dell’impulso sessuale, mentre altri sono assai meno rigorosi oppure ignorano dei tutto il problema. Vi sono manuali di hatha-yoga i quali, mentre si preoccupano di dare tutta una serie di regole igieniche e dietetiche, non dedicano neppure una riga al problema dei comportamento sessuale: eppure la sessualità è una componente cosi importante della vita umana che lo yogin non può fare a meno di interrogarsi sul corretto atteggiamento da tenere di fronte al cosiddetto «problema dei sesso».
Se risaliamo alle fonti dei pensiero indiano rischiamo, anziché chiarirci le idee, di confondercele ancora di più. Da un lato infatti troviamo maestri di primissimo piano, come Vivekânanda e Aurobindo, che si sono pronunciati a favore di un radicale controllo dell’impulso sessuale; al polo opposto abbiamo invece la tradizione tantrica, la quale ha sviluppato tutta una serie di tecniche basate su di un appropriato uso della sessualità. Entrambe le posizioni, in apparenza inconciliabili, hanno in realtà una matrice comune; si tratta dell’idea, peculiare, sebbene non esclusiva, dei pensiero indiano, che la sessualità è una forma di energia, suscettibile di essere trasformata in un’altra forma di energia di livello superiore. in sanscrito questa speciale energia è denominata ojas.
Questo processo di trasformazione implica la rinuncia alla sessualità ordinaria, che viene in tal modo «sublimata», oppure, come nel tantrismo, la sua attuazione in forma rituale e sacrale, sicché il rapporto tra uomo e donna viene trasfigurato, trasformandosi in unione divina. La prima alternativa corrisponde invece a quel processo che Freud ha chiamato «sublimazione della libido»: al padre della psicanalisi non era infatti sfuggita questa possibilità dell’istinto sessuale di trascendere la funzione biologica per configurarsi come un vero e proprio potenziale energetico.
La prescrizione dei brahmacarya ha per scopo la capitalizzazione e la trasformazione dell’ojas: questo yama comporta quindi un controllo delle pulsioni sessuali e la loro riconversione su un piano più elevato. Per il seguace dello hatha-yoga il brahmacarya significherà il dominio dei propri istinti e la realizzazione di una sessualità armonica, equilibrata, senza eccessi, ma anche senza ascetiche rinunce. Del resto anche nella tradizione indiana lo stato di brahmacârin non è una condizione definitiva se non per individui eccezionali: di norma, alla pratica temporanea della continenza da parte dello studente celibe segue lo stato di capofamiglia (grihastha) il cui dovere consiste nel realizzarsi come buon marito e padre. Solo dopo aver compiuto la propria parte nel mondo, l’uomo, facendosi sannyâsin, rinuncerà alla vita degli affetti e dei sensi per votarsi interamente alla ricerca spirituale e all’ascesi.
Alla luce di questi chiarimenti, come si configura il precetto dei brahmacarya per il moderno yogin occidentale? In linea di massima è consigliabile far precedere l’inizio della pratica da un breve periodo di continenza, atto a favorire le migliori condizioni psicofisiche nella fase di iniziazione. Successivamente avremo cura di attenerci alla via dell’equilibrio, evitando gli opposti dell’austerità ascetica e della ricerca edonistica. Più di ogni altra cosa è importante un corretto atteggiamento mentale ed emotivo nei confronti della sessualità: lungi dal considerarla come qualcosa di impuro o peccaminoso lo yogin saprà attribuirle, nel contesto dinamico della propria esistenza, il giusto posto che le compete, guardando con compassionevole distacco all’ossessiva importanza che molti attribuiscono al sesso, ma evitando, nel contempo, ogni forzatura ascetica. Vi è un celebre detto orientale: «Come l’erba kusha, male afferrata, taglia le mani, così l’ascesi, male intrapresa, conduce alla rovina». Conviene meditare attentamente su questa verità, che ci invita ad accettarci per quello che siamo. Viviamo con pienezza e sincerità la nostra condizione umana: lo yoga, con la sua azione riequilibratrice che investe tutta la personalità, potrà aiutarci a conseguire, nella realizzazione della sessualità, quello stadio oblativo, come è denominato dalla moderna psicologia del profondo, in cui l’atto amoroso è vissuto come dono e che si accompagna, nella vita di relazione, alla creatività, alla generosità e all’altruismo.
APARIGRAHA O «NON-POSSESSO»
La quinta e ultima delle cinque astinenze riguarda il divieto di possedere, nel senso di essere liberi dall’eccessivo attaccamento ai beni materiali. Come ha sottolineato Fromm nel suo celebre Avere o essere, l’uomo si trova costantemente a dover scegliere tra una realizzazione egoistica e, in definitiva, inautentica nella categoria dell’avere (possesso, dominio, accumulo), e una realizzazione priva di egoismo, libera, intesa al potenziamento delle qualità interiori, anziché all’ammassamento di beni, nella categoria dell’essere. è evidente che un’eccessiva preoccupazione per l’avere costituisce un ostacolo sulla via di un reale progresso spirituale e poiché produce ansietà e turbamento impedisce quello sviluppo armonico della persona che è la meta dichiarata dello hatha-yoga.
È pur vero che per poter «essere» occorre, in una certa misura, anche «avere»: nessuno vuole imporre al moderno yogin occidentale una vita di povertà francescana, ideale nobilissimo che però richiede una non comune vocazione. Ancora una volta ciò che si raccomanda è Il giusto mezzo: un’onesta ricerca del benessere materiale per se stessi e per i propri familiari non è un impedimento sulla via dello hatha-yoga.
Ad aparigraha si connette pure il divieto, espresso nei testi, di ricevere doni che creano legami e obblighi. Questa specifica prescrizione, nata per gli adepti di ordini religiosi, ai quali è vietata ogni forma di possesso, non può essere applicata alla lettera dall’occidentale che intraprende lo yoga. Lasciando ancora una volta in disparte ogni formalismo, può ben essere motivo di riflessione lo spirito che anima questo precetto: quello di conservarci, in ogni circostanza, liberi da obblighi che costituiscono un condizionamento morale e rischiano di spingerci a degradanti compromessi.
LA TENSIONE E LE SUE FORME
Vi proponiamo innanzitutto alcuni esperimenti di autoconsapevolezza. Provate a osservarvi mentre alla guida della vostra auto vi recate verso il luogo di lavoro o percorrete un’autostrada per un lungo viaggio. Cercate di percepire tutte le sensazioni muscolari che provengono dalle diverse parti del corpo: avete il viso contratto o la fronte corrugata? I vostri occhi guardano fissamente senza sbattimento delle palpebre? Le vostre mani serrano con forza il volante? Il vostro collo è teso e rigido? Le vostre spalle sono sollevate? Sentite tensione alla bocca dello stomaco? I muscoli addominali sono contratti? Riuscite a respirare liberamente? Avvertite dei crampi alle gambe? Vi dolgono i piedi e le caviglie mentre pigiate il freno e la frizione?
Un secondo esperimento di osservazione può essere praticato nei momenti in cui siete preda di una forte emozione, per esempio ira o ansia. Provate allora a sentire quali sono i muscoli mobilitati nell’espressione di quella particolare emozione, che tipo di modificazione avvertite nel battito cardiaco e nella respirazione, quali movimenti effettuate con le braccia o con le mani, come si atteggiano i muscoli facciali, che genere di sensazione avvertite a livello energetico dopo la crisi emotiva.
Cercate infine di diventare consapevoli del vostro stato quando siete sottoposti a un surménage di lavoro: che cosa sentite a livello mentale? Qual è la vostra situazione fisica generale? Da che cosa proviene quel blocco che vi impedisce di continuare o rallenta il vostro ritmo di lavoro, come se la vostra mente rifiutasse di proseguire nelle sue operazioni, proprio come un computer subissato di richieste che eccedono le sue capacità di elaborazione? Sentite un vuoto alla testa? Avete delle cefalee?
Questi tre esperimenti vogliono stimolarvi a diventare coscienti dei tre tipi prevalenti di tensione o, meglio, dei tre livelli a cui la tensione psicofisica può manifestarsi: fisico, emotivo e mentale.
È bene rammentare che un certo tono muscolare o tensione è un fattore naturale indispensabile per mantenere la vita biologica e per effettuare qualsiasi attività. Tale tono è determinato dagli impulsi nervosi che mantengono i muscoli in uno stato di leggera contrazione, impedendo loro di accasciarsi o slegarsi, e azionano certi organi come il cuore e i polmoni. Anche quando dormiamo il nostro corpo mantiene una certa tensione. Se ricorressimo a una scala per misurare i vari livelli del tono stesso, scopriremmo che il massimo livello di tensione (100%) si ha solo in certe forme di parossismo muscolare patologico, mentre il livello medio del tono muscolare si aggira attorno al 70-80%. Tale livello cala bruscamente al 38% quando il sonno produce i suoi effetti riparatori sul corpo. È comunque necessario che la tensione stessa non sia inferiore al 26%, soglia al di sotto della quale il corpo non potrebbe mantenere le sue funzioni e incomincerebbe il processo irreversibile della morte.
Il problema che noi tutti dobbiamo affrontare è quello delle tensioni parassite o eccessive che producono un gigantesco dispendio di energia a livello psicofisico. Una risposta non adeguata agli stimoli esterni o ai contenuti emergenti di volta in volta dall’inconscio provoca un aumento della tensione o tono muscolare che, accumulato nel tempo, produce un punto di rottura denominato stress. Questo è appunto un sovraccarico continuo di tensione non smaltita che si ripercuote sia a livello nervoso e muscolare sia a livello psichico. In un essere umano sottoposto a stress il corpo incorre in patologie che interessano gli organi più deboli o sottoposti a maggiore tensione, mentre a livello psichico si nota un aumento dell’ansia che si tramuta presto in depressione, a cicli alterni, tale da portare rapidamente al crollo delle capacità di adattamento e di risposta alle situazioni e alle richieste del mondo esterno.
Poiché la mente e il corpo agiscono, come insegna lo yoga, non già su un piano di semplice interazione o di parallelismo, ma a un livello di stretta cooperazione, è necessario anzi tutto individuare a quale livello la tensione si produce per poter effettuare l’opportuna azione di rilassamento. È importante, per esempio, sapere se la tensione è dovuta a inibizione o a eccesso di azione: nell’un caso essa può essere alleviata attraverso una adeguata espressione o manifestazione esterna, nell’altro caso solo il riposo servirà a eliminarla.
Allo stesso modo, è importante essere consapevoli se la tensione è soprattutto fisica o emotiva o mentale, anche se esiste un coinvolgimento degli altri livelli. Come tutti sanno per esperienza propria, qualsiasi evento si verifichi sul piano mentale ed emotivo si manifesta istantaneamente anche sul piano fisico, così come qualsiasi modificazione fisica si riflette immediatamente sul piano psichico e mentale. Di fatto, mente e corpo si comportano come manifestazioni vibratorie diverse di una stessa energia prodotta dall’azione della prakriti (natura universale). In tal modo, pensieri ed emozioni si fanno corpo, mobilitando certi muscoli, sollecitando certi organi e ghiandole e plasmando a lungo andare, in base alla loro qualità e frequenza, il corpo fisico stesso, in taluni casi creando vere e proprie «corazze caratteriali».
UN CAPITALE PREZIOSO: L’ENERGIA
II problema dell’energia psicofisica e della sua economia è forse uno degli assilli principali dell’uomo nella società moderna. Ogni essere possiede un capitale energetico non illimitato e neppure fisso, che può essere accresciuto attraverso particolari tecniche insegnate dallo yoga, soprattutto legate al prânâyâma. Ma prima di fare ricorso alle tecniche che permettono di aumentare il capitale energetico stesso, occorre diventare oculati amministratori dell’energia che si ha a disposizione, osservando in quali modi la spendiamo nel corso della giornata: solo così potremo evitare di «andare in rosso» e di accumulare uno «scoperto energetico» che nessuno o nulla potrà coprire.
Secondo lo yoga tutte le attività che l’uomo effettua prima di giungere alla liberazione (moksha), cioè lo stato che dona all’essere umano una coscienza pura e gioiosa e fa di lui un realizzato, il quale vive ormai libero dai conflitti e dalle sofferenze della quotidianità e dell’illusione cosmica, si possono ricondurre a quattro: 1) âhara, l’attività del nutrimento attraverso il cibo, il respiro e le impressioni sensoriali; 2) nihara, l’attività che comprende sia il movimento necessario a mantenere in buono stato il corpo sia il lavoro che ci permette di procurarci di che vivere; 3) maithuna, l’amore e i rapporti sessuali, la sfera di attività che permette ad ogni essere umano di trovare un completamento affettivo e sessuale; 4) nidrâ, il dormire, l’attività riparatrice e benefica che annulla gli shock fisici ed emotivi cui è sottoposto l’organismo nello stato di veglia.
Ognuno dovrebbe cercare di scoprire in che modo ripartisce la sua energia in queste quattro attività, in modo da non spendere troppo prâna nell’una o nell’altra di esse. Inoltre, dovrebbe diventare consapevole del fatto che le emozioni negative, come l’ansia, l’irritazione, l’ira, la paura, siano esse espresse o no, dilapidano in poco tempo il capitale energetico quotidiano, lasciando in pochi istanti svuotati e prostrati oppure determinando quelle patologie di fatica vitale o astenia cronica che sono il sintomo di una protratta usura emotiva.
Non solo è quindi necessario ben distribuire le proprie risorse energetiche nelle varie attività e non sprecarle in emozioni negative, ma è anche indispensabile compiere nel giusto modo ogni attività stessa. Occorre cioè scoprire, guidati soprattutto dalla consapevolezza di sé che lo yoga tende a incrementare sempre più, qual è il modo più vero, e quindi più armonico ed efficiente, di compiere tutto ciò che siamo chiamati a compiere con il minor dispendio di energia possibile. È questa la scienza che viene chiamata Shâstra, o scienza (del buon funzionamento), applicabile sia ai doveri del nostro stato e della nostra condizione psicofisica in rapporto alla legge cosmica suprema cui tutti siamo soggetti (dharma-shâstra), sia all’attività con la quale ci procuriamo i mezzi per vivere (artha-shâstra), sia ai modi con cui cerchiamo di soddisfare i nostri desideri primari (kâma-shâstra). Esiste in ultimo anche un moksha-shâstra, la scienza che insegna a trasformare desideri, necessità e istinti per giungere alla liberazione: tale scienza è considerata il culmine dello yoga vero e proprio.
Solo quando saremo riusciti, attraverso un paziente lavoro di consapevolezza, a mettere ordine all’interno delle energie vitali, tutte le nostre disfunzioni e malattie fisiche e psichiche saranno sanate. Per fare questo, però, dobbiamo rifarci preliminarmente alla pratica di yama e niyama di cui si è inizialmente parlato, e ricorrere anche a quel consapevole abbassamento del livello della tensione che si ottiene attraverso le tecniche del rilassamento e della yoga-nidrâ.
IMPARIAMO A RILASSARCI
Secondo lo hatha-yoga il rilassamento (shaithilya) consiste nel ridurre in modo consapevole il livello di tensione neuro-muscolare, portandolo ad un valore che si colloca tra il 38% e il 26% sulla scala percentuale di cui abbiamo parlato. Ciò presuppone anzitutto che ci abituiamo a poco a poco a diventare consapevoli delle tensioni che si annidano in noi sia a livello fisico che a livello emotivo e mentale. Solo allora potremo allentarle, scioglierle e disperderle usando il potere suggestivo della nostra mente che può inviare messaggi e ordini positivi ai vari muscoli, non solo a quelli striati, ma anche a quelli lisci, che sono considerati relativamente indipendenti dal sistema nervoso centrale. Il rilassamento yogico è quindi tutto l’opposto del relax così com’è comunemente inteso: esso è soprattutto un innalzamento del livello di consapevolezza su tutti i piani. Mentre la separazione della mente dal corpo comporta quel notevole aggravio di tensioni che tutti noi registriamo alla fine di ogni giornata, l’immersione sempre più profonda della coscienza nel corpo, il sentire cioè pienamente ciò che siamo e come siamo, permette un rapido riequilibrio delle energie che circolano in tutto il nostro essere, anche a livelli sottili.
Per praticare il rilassamento occorre anzitutto abbandonare la modalità fondamentale che regola il nostro comportamento sociale: lo sforzo attraverso l’azione. Nel rilassamento infatti si tratta di adottare un’attitudine di non-sforzo e di non-azione lasciando che il sistema di autoregolazione, manomesso dalla mente e dalle emozioni, rientri in funzione attraverso l’attenzione consapevole. Attraverso di essa recuperiamo la più ancestrale abitudine connessa col sistema neurovegetativo, quella del sentire e del provare sensazioni, accantonando per un po’ la mente che giudica, discorre, classifica e contrappone.
Nel rilassamento possiamo individuare due momenti. Il primo è la fase in cui lasciamo cadere e abbandoniamo. Entrando nella stanza dove pratichiamo il rilassamento, lasciamo fuori il nostro ego, il nostro ruolo, le nostre preoccupazioni, i nostri pregiudizi, le nostre paure e ansietà; lasciamo cioè cadere quella sovrastruttura che ci serve come moneta di scambio nei rapporti sociali e interpersonali e privilegiamo invece il corpo, il respiro, le sensazioni, il fatto di essere vivi, in una parola /’essere. Il secondo momento è un arrendersi e un aprirsi più profondo. Distesi e abbandonati come uno straccio gettato per terra ci arrendiamo al nostro vero essere, alla nostra vera natura, a una più alta consapevolezza. Realizziamo allora con tutto il nostro essere un movimento simile a quello di una mano che si apre Mentre prima sprecavamo tutte le nostre energie per tenerci in pugno e mantenere in piedi una fortezza dove ci difendevamo da noi stessi e dagli altri ora ci lasciamo andare completamente, vincendo la profonda resistenza insita in ognuno ad abbandonarsi e arrendersi a un tutto più vasto.
Allora comincia la fase della consapevolezza, attraverso cui caliamo la coscienza sempre più profondamente nel corpo, finché tutte le tensioni sedimentate nei muscoli e negli organi in seguito al lavorio incessante di pensieri, emozioni, impulsi si liberano e l’energia torna a fluire liberamente come l’acqua in un canale pulito.
A livello fisico, utilizzando la particolare ricettività dell’inconscio, invieremo messaggi di rilassamento e di riposo non solo ai muscoli e agli organi volontari, ma anche a quelli che sembrano sfuggire al nostro controllo e che pure necessitano di distensione, come il cuore, il fegato, i reni.
Attraverso la respirazione lenta e ritmica cercheremo invece di calmare la nostra mente e di renderla tranquilla e silenziosa, visualizzandola come la superficie immobile di un lago.
A livello spirituale, infine, ci apriremo al nostro vero Sé, alla Coscienza pura e incontaminata, sorgente di tutte le energie, che sola può riequilibrare il nostro intero essere.
Il rilassamento supino (Shava-âsana)
Tale postura significa «posizione del cadavere», ma potrebbe essere designata più propriamente come shânti-âsana, «posizione di serenità e pace».
Il termine «postura del cadavere» fa riferimento a quell’atteggiamento psicologico di abbandono di ogni tensione, preoccupazione o pensiero che occorre assumere per ottenere un vero rilassamento. Questo lasciare la presa da se stessi e dal mondo esterno si configura infatti come una morte momentanea vera e propria.
Esecuzione. Distendetevi supini, con le gambe leggermente divaricate, le braccia scostate dal corpo con il palmo rivolto verso l’alto e gli occhi chiusi (figura a). Respirate in modo calmo e tranquillo alcune volte ripetendo, se vi può aiutare, la parola shânti (o «pace») oppure la formula: «lo sono perfettamente calmo». Quindi scuotete la gamba destra, muovendo nei due sensi il piede, poi rilassatela. Flettete, sempre, o inspirando, la gamba destra all’altezza del ginocchio, mantenendo il tallone a contatto con il suolo, poi lasciatela cadere a terra con una subitanea espirazione. Fate lo stesso con la gamba sinistra.
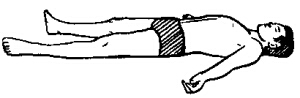 |
| Figura a |
Contraete alcune volte le natiche, poi rilassatele; fate lo stesso con lo sfintere anale, sentite i punti di contatto con il pavimento dei muscoli della schiena e immaginate di sprofondare nella terra. Poi scuotete alcune volte il braccio destro e lasciatelo andare; lo stesso fate con il braccio sinistro.
Portate ancora l’attenzione per qualche istante sulla respirazione, allentate la mascella inferiore, dilatate i muscoli del viso aprendo occhi e bocca come se steste per gridare, poi serrateli come se voleste ridurre il volume del viso, indi rilasciateli. Fate questo alcune volte, poi riposate completamente per un po’ di tempo (fino a mezz’ora) facendo attenzione a non addormentarvi e mantenendo l’attenzione sul respiro.
Dopo essere rimasti per un certo tempo in uno stato di perfetto abbandono, eseguite alcuni esercizi di ripresa: muovete lentamente le dita della mano destra, poi quelle della mano sinistra. Chiudete poi le mani a pugno molto lentamente e ispirando portatele verso le spalle. Espirando, riportatele a terra con il palmo aperto. Fate questo tre volte. Indi stiratevi in tutto il corpo come se vi svegliaste da un sonno profondo e aprite lentamente gli occhi.
Variante. Sdraiatevi per terra sul fianco destro, stendete il braccio destro davanti a voi col palmo rivolto verso l’alto e appoggiate su di esso la testa come se voleste dormire. Piegate la gamba sinistra ali altezza del ginocchio e collocatela al suolo davanti alla gamba destra che rimane tesa. Appoggiate il braccio sinistro sul fianco corrispondente (figura b). Portate allora la vostra attenzione sul respiro: poiché l’emitorace destro è bloccato poggiando contro il pavimento o la terra, percepirete la respirazione a livello dell’emitorace sinistro Rimanete da cinque a dieci minuti in questa postura poi cambiate fianco assumendo la posa simmetrica corrispondente e prendendo coscienza della respirazione a livello dell’emitorace destro.
 |
| Figura b |
Variante: il rilassamento rapido (shîghra-shava-âsana).
Sdraiatevi supini, quindi, inspirando, sollevate di scatto da terra le gambe divaricate, il busto, la testa e le braccia serrando i pugni e tendendo fortemente tutti i muscoli del corpo: fate ciò bilanciandovi sulle natiche e sulla parte terminale della schiena (figura c). Poi, espirando, rilasciate tutti i muscoli e ritornate rapidamente al suolo. Scuotete, come abbiamo indicato prima i muscoli delle gambe e delle braccia, contraete e decontraete i muscoli del viso, indi rilassatevi in shava-âsana.
 |
| Figura c |
Distendetevi a pancia in giù con le gambe divaricate e i piedi rivolti verso l’esterno. Agli inizi avrete una certa difficoltà a poggiare il malleolo piatto contro il suolo ma non forzate. Incrociate davanti a voi le braccia all’altezza dei gomiti e appoggiate la fronte al centro dell’incrocio: in tal modo il torace sarà in parte sollevato dal suolo insieme alla testa (figura a). Portate I attenzione sul respiro e poi sul battito cardiaco. Rimanete in tale postura, particolarmente benefica per il cuore, da 10 a 15 minuti o più.
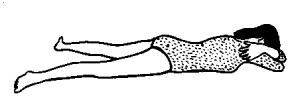 |
| Figura a |
Variante. Distendetevi proni con le gambe unite, indi sollevate da terra la testa e il busto, appoggiando il mento sulle palme unite delle mani che premono contro le guance, mentre i gomiti puntano contro il suolo. Rilassate il resto del corpo e chiudete gli occhi (figura b). Tale postura, che può essere mantenuta a lungo quanto si vuole, è benefica per tutti i disturbi della colonna vertebrale.
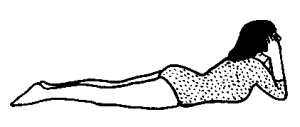 |
| Figura b |
Il rilassamento facile (jyestha-âsana)
Stendetevi proni con le gambe unite e la fronte contro il suolo. Poi intrecciate le mani sulla nuca rilassando completamente tutto il corpo. Prendete coscienza del respiro e in particolare della pressione dell’addome contro il suolo.
Il Buddha dormiente (sayana-Buddha-âsana)
Sdraiatevi sul fianco sinistro, mantenendo le gambe una sull’altra e il braccio destro disteso lungo il fianco corrispondente. Piegate il braccio sinistro con il gomito a terra e con il palmo sostenente saldamente la testa (figura) Portate l’attenzione sul respiro.
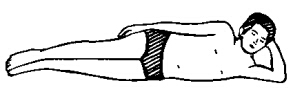 |
Assumete questa postura, che è quella di molte statue che rappresentano il Buddha disteso, quando volete rilassarvi senza dormire.
Il bastone (danda-âsana)
La posizione purificatrice (pavana-mukta-âsana)
II sollevamento del bacino (upastha-utthapana-âsana)
II pesce (matsya-âsana)
La semi-cavalletta (ardha-shalabha-âsana)
La folgore (vajra-âsana)
La consapevolezza del respiro (introduzione al prânâyâma}
In questa posizione, che è un esercizio di contrazione-decontrazione, il corpo giace disteso a terra come un bastone. Nella seduta del mattino danda-âsana si esegue prima delle altre posture, per favorire il ripristino del giusto tono muscolare dopo il riposo notturno. Nella seduta pomeridiana è meglio invece praticare questa tecnica subito dopo il rilassamento iniziale in shava-âsana.
Posizione di partenza. Supini, gambe unite e ben distese, braccia lungo i fianchi.
Fase di movimento. Inspirando, sollevate le braccia in modo lento e uniforme, senza piegarle e, descrivendo un semicerchio, portatele oltre il capo: quando raggiungono il suolo intrecciate le dita e fate ruotare le palme verso l’esterno, in modo che il dorso delle mani sia rivolto verso il capo.
Immobilizzazione. Trattenendo il fiato, stirate energicamente il corpo come se voleste allungarlo il più possibile (figura).
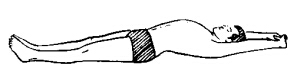 |
Fase finale. Espirando, allentate la tensione muscolare fino ad annullare completamente lo stiramento. Ritornate nella Posizione di partenza.
Durata. L’Immobilizzazione, effettuata in apnea, sarà necessariamente piuttosto breve: dai 5 ai 15 secondi. L’intero ciclo può essere ripetuto 2 o 3 volte.
Atteggiamento mentale. Concentratevi, in particolare, sulla fase immobile di stiramento, visualizzando due forze eguali e contrarie che agiscono sul corpo. Prendete successivamente coscienza della rapida decontrazione, che va di pari passo con l’atto di espirare, con passaggio dallo stiramento al rilassamento.
Effetti. Questo âsana, pur nella sua semplicità che lo rende privo di controindicazioni, esercita una molteplice azione. Esso infatti tonifica tutta la muscolatura, in particolare la fascia addominale e dorsale. I suoi effetti più salutari riguardano però la colonna vertebrale: lo stiramento opera infatti come un eccellente correttivo dei paramorfismi ed è particolarmente indicato nella prevenzione della scoliosi.
La posizione purificatrice (pavana-mukta-âsana)
Il nome sanscrito di questo âsana significa, letteralmente, «posizione che libera dall’aria»: il principale effetto di questa tecnica è infatti quello di favorire l’eliminazione dei gas intestinali. È un esercizio adatto a entrambe le sedute della giornata, con una preferenza per quella pomeridiana.
Posizione di partenza. Sdraiatevi supini, come in sava-âsana, ma con le gambe unite. Rilassatevi per qualche istante allentando ogni tensione e respirando normalmente in modo calmo e profondo.
Prima fase di movimento. Sollevate da terra la gamba destra, piegatela e portate il ginocchio verso l’addome con un movimento lento e uniforme: quando è abbastanza vicino abbracciate la gamba appena al di sotto del ginocchio ed esercitate con gli avambracci una trazione in modo da portare il ginocchio stesso a premere contro il petto. Nello stesso tempo sollevate la testa e le spalle, così che il mento venga a poggiare sul ginocchio. Tutta la Fase di movimento deve coincidere con una espirazione.
Prima immobilizzazione. Rimanete nella posizione indicata dalla figura a, respirando normalmente.
Seconda fase di movimento. Liberate la gamba dalla stretta degli avambracci e riportatela adagio nella posizione iniziale: fate ciò inspirando, dopo aver vuotato a fondo i polmoni, abbassando nel contempo le spalle e il capo. Rilassatevi in posizione supina respirando normalmente, quindi ripetete il primo movimento con la gamba sinistra.
Seconda immobilizzazione. È identica alla precedente (figura a), con la differenza che la gamba destra ora è distesa, mentre la sinistra è piegata contro li petto.
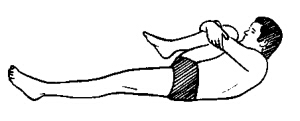 |
| Figura a |
Terza fase di movimento. Dopo essere di nuovo ritornati nella posizione di partenza ed esservi brevemente rilassati, piegate entrambe le gambe portando le ginocchia, sempre unite, verso il petto. Eseguite anche questo movimento in fase di espirazione. Quando le ginocchia sono in prossimità del petto, abbracciatele, come avete fatto prima con una sola gamba, sollevando da terra la testa e le spalle, in modo che il mento venga a trovarsi fra le ginocchia.
Terza immobilizzazione. Restate nella posizione della figura b, respirando normalmente, senza allentare la trazione degli avambracci.
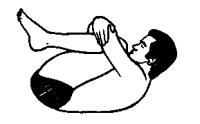 |
| Figura b |
Fase finale. Rilasciate le gambe e ritornate con un’espirazione nella posizione di partenza, facendo lavorare gli addominali attraverso una lenta discesa degli arti inferiori distesi. Posate le mani sull’addome, appena al di sotto del diaframma, e rilassatevi respirando normalmente.
Durata. Per la prima e seconda immobilizzazione: 30 secondi. La terza Immobilizzazione può essere protratta fino a 2-3 minuti.
Atteggiamento mentale. Durante la fase di movimento concentrate l’attenzione sulla flessione della gamba (o di entrambe le gambe) percorrendo mentalmente l’arto dalla punta del piede all’inguine.
Durante la fase di immobilizzazione concentratevi sulla pressione della gamba (o di entrambe le gambe) contro l’addome.
Al termine, con le palme delle mani abbandonate sul diaframma, concentratevi sul ritmo lento e profondo della respirazione addominale.
Effetti. Questo âsana esplica la sua efficacia in particolare sull’addome: tutti i visceri vengono massaggiati e tonificati. L’intestino soprattutto trae giovamento da questa tecnica, la quale, come si è detto all’inizio, è specialmente indicata a chi soffre di eccesso di gas intestinali (meteorismo). Si ha poi un’azione stimolante sulla peristalsi che può risolvere molti casi di stitichezza ostinata.
Controindicazioni. In caso di infiammazioni intestinali acute, appendicite, ecc., è bene praticare con cautela questa posizione.
Il sollevamento del bacino (upastha-utthâpana-âsana)
Questo âsana comprende due varianti che hanno effetti alquanto diversi: nella prima l’immobilizzazione è trascurabile, nella seconda invece l’efficacia dell’esercizio consiste tutta proprio nella fase statica. Entrambe le varianti sono adatte sia alla seduta del mattino che a quella serale.
PRIMA VARIANTE
Posizione di partenza. Supini, braccia distese lungo i fianchi con le palme rivolte in basso. Le gambe sono piegate, le ginocchia unite, i talloni il più vicino possibile alle natiche, le piante dei piedi ben poggiate al suolo (figura a).
 |
| Figura a |
Fase di movimento. Con una profonda espirazione vuotate completamente i polmoni, quindi inspirate, sollevando contemporaneamente il bacino e il dorso, mentre le spalle e le braccia rimangono rilassate. La durata del sollevamento del bacino coincide con quella di una lenta e profonda inspirazione.
Immobilizzazione. Trattenendo il fiato, rimanete per 3 o 4 secondi nella posizione della figura b.
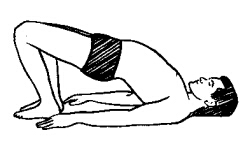 |
| Figura b |
Fase finale. Espirando, abbassate lentamente il bacino, ritornando nella posizione della figura a. Breve Immobilizzazione a polmoni vuoti.
Durata. L’intero ciclo, corrispondente ad un atto respiratorio completo, deve essere ripetuto da 5 a 10 volte.
Atteggiamento mentale. Nella posizione di partenza concentrate l’attenzione sulla spina dorsale. Poiché le gambe sono piegate, viene modificata la curva fisiologica delle vertebre dorso-lombari. La colonna vertebrale viene così ad aderire perfettamente al suolo: prendete coscienza di questo contatto. Nella fase di movimento concentratevi sull’inarcamento del dorso e sulla respirazione, come se fosse l’atto stesso dell’inspirazione a causare il sollevamento del bacino e della spina dorsale. I muscoli del viso e del collo devono restare rilassati.
SECONDA VARIANTE
Posizione di partenza e Fase di movimento. Sono identiche a quelle della prima variante: una volta sollevato il bacino, piegate le braccia e portate le mani sotto le reni a sostenere il dorso.
Immobilizzazione. Rimanete nella posizione della figura c. A differenza della prima variante l’immobilizzazione non si effettua in apnea, ma respirando normalmente. Poiché il mento preme contro lo sterno la respirazione sarà necessariamente addominale.
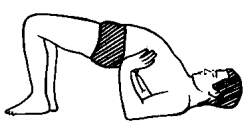 |
| Figura c |
Fase finale. Riportate le mani lungo i fianchi, abbassando il bacino e ritornando nella posizione di partenza.
Durata. L’immobilizzazione può essere protratta da 1 minuto fino a 3-4 minuti.
Atteggiamento mentale. Concentratevi sulla respirazione addominale, lenta e profonda.
Effetti. Come si è detto, le due varianti agiscono in modo totalmente diverso, pur avendo entrambe effetto rilassante.
Prima variante:
- Tonifica la spina dorsale, massaggia le vertebre e conferisce elasticità al dorso.
- Coadiuva nella terapia della scoliosi e delle lombalgie.
Seconda variante:
- Favorisce la respirazione addominale.
- Agisce sui visceri, riequilibrandone la funzionalità.
Controindicazioni. Entrambe le varianti devono essere praticate con prudenza nel caso di artrosi cervicale in fase acuta.
Nello yoga e in generale nella mitologia indiana il pesce è una figura importante. Si narra infatti che fu proprio un pesce a carpire a Shiva, per poi rivelarli agli uomini, i segreti dell’insegnamento esoterico che quel dio andava impartendo alla sposa Parvatî: così, secondo la leggenda, ebbe origine lo hatha-yoga.
Il pesce è anche l’incarnazione del dio Vishnu che reca in salvo Manu (il progenitore dell’umanità) attraverso le acque del diluvio. Correttamente eseguito in acqua, matsya-âsana consente al corpo di galleggiare, più o meno come quando si fa il morto: non è chiaro però se sia questa peculiarità, oppure il riferimento al mito, ad aver dato il nome alla posizione.
L’esecuzione classica dell’âsana avviene con le gambe incrociate nella posizione del loto: la variante che descriveremo, a gambe distese, è quindi assai facilitata e adatta a entrambe le sedute della giornata.
Posizione di partenza. Supini, come in shava-âsana.
Fase di movimento. Unite le gambe e portate le mani sotto il dorso all’altezza dei fianchi. Piegate le braccia e puntate i gomiti sul pavimento; poi, espirando, sollevate il busto, il collo e il capo.
Inarcate ora fortemente all’indietro il busto e il collo: mentre le gambe rimangono rilassate e distese il resto del corpo forma un arco, in cui soltanto il bacino e la sommità del cranio poggiano al suolo. Liberate le braccia e congiungete le mani sul petto.
Immobilizzazione. Mantenete la posizione della figura, respirando normalmente.
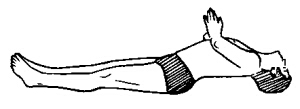 |
Fase finale. Riportate le mani sotto i fianchi a sostenere il dorso; poi, espirando, sollevate il capo e distendete il collo; quindi abbassate le spalle, ritornando nella posizione di partenza.
Durata. Da 15 secondi a 1 minuto di immobilizzazione.
Atteggiamento mentale. Concentratevi sul plesso solare, sui movimenti respiratori del diaframma, e sulla tensione addominale causata dal forte inarcamento.
Effetti. Questo âsana agisce sugli organi addominali e sull’apparato respiratorio: gli asmatici, in particolare, ne traggono sollievo. Opera anche come coadiuvante nella terapia della scoliosi.
Controindicazioni. Ipertiroidismo, artrosi cervicali in fase acuta.
La semi-cavalletta (ardha-shalabha-âsana)
La posizione della cavalletta completa comporta un notevole sforzo dei muscoli della fascia dorsale: anche gli yogin esperti riescono a mantenerla per un tempo piuttosto breve. Alla portata di tutti è invece la semi-cavalletta, la quale, praticata con assiduità, rinforza progressivamente la muscolatura del dorso e serve così da preparazione alla posizione completa.
Questo esercizio può essere praticato sia nella seduta del mattino che in quella serale.
Posizione di partenza. Proni, braccia lungo il corpo, palme in basso, gambe unite; il viso poggia al suolo con il mento. Rilassatevi per qualche istante respirando normalmente.
Fase di movimento. Inspirate profondamente: quando l’inspirazione è quasi completa sollevate adagio la gamba destra, portandola più in alto possibile, senza piegarla e senza alzare il bacino.
Immobilizzazione. Rimanete nella posizione della figura, respirando normalmente. Una eventuale sensazione di calore nella parte posteriore della coscia è un fenomeno del tutto normale che attesta l’efficacia dell’esercizio.
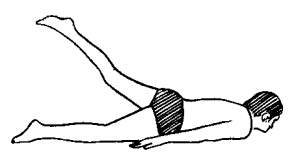 |
Fase finale. Espirando, riportate lentamente la gamba al suolo. Rilassate tutto il corpo per qualche istante prima di ripetere il movimento con l’altra gamba.
Durata. Si incomincia con un’immobilizzazione di 5 secondi, aumentando progressivamente fino a 15-20 secondi.
Atteggiamento mentale. Visualizzate il corpo come diviso longitudinalmente in due parti: una completamente inerte e rilassata, l’altra in tensione. Nell’eseguire il ciclo completo prendete coscienza dello scambio di ruoli tra le due parti.
Effetti. I muscoli della fascia dorso-lombare vengono tonificati e irrobustiti: si ha quindi una prevenzione della lombalgie e delle sublussazioni vertebrali. Anche i muscoli delle gambe vengono irrobustiti. L’âsana ha inoltre un benefico effetto sui visceri addominali e agisce come stimolante dell’appetito.
In sanscrito vajra significa, oltre che «fulmine», anche «diamante»: in alcuni testi questo âsana viene quindi presentato con il nome di «posizione del diamante». Entrambe le denominazioni stanno ad attestare che si tratta di una tecnica capace di conferire un’eccezionale carica energetica, simbolegqiata dalla potenza folgorante del fulmine come dalla cristallina purezza del diamante la pietra, che nulla può scalfire: ciò è confermato anche da un’altra denominazione, quella di vîra-âsana o «posizione dell’eroe», con cui la postura è chiamata da altri maestri.
Come tutte le posizioni sedute, vajra-âsana è indicato in modo particolare per la meditazione e il prânâyâma: si tratta infatti di una tecnica essenzialmente statica, nella cui esecuzione non esiste una vera e propria fase di movimento.
Variante facile. Mettetevi in ginocchio, tenendo le gambe ben ravvicinate: il dorso dei piedi è a contatto del pavimento. Sovrapponete il piede destro al sinistro, o viceversa, ma solo nella parte prossima alle dita, mentre i talloni rimangono scostati, e abbassate poi il bacino in modo da sedervi sui talloni stessi. Abbiate cura di non afflosciare la spina dorsale: la schiena deve essere ben diritta, ma non rigida, e deve formare un’unica linea retta con il collo e il capo. Le mani possono essere posate sulle ginocchia con le palme in basso, oppure essere raccolte in grembo una sull’altra con le palme rivolte in alto (figura a).
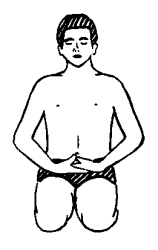 |
| Figura a |
Variante avanzata. La variante precedente non presenta alcuna difficoltà e dopo qualche tempo potrete apprezzarne i vantaggi e adottarla, nell’intimità della vostra casa, anche per la lettura, lo studio o altre occupazioni intellettuali. Si tratta però di una variante facilitata: la posizione classica si assume allontanando i talloni l’uno dall’altro, in modo che vengano a trovarsi ai due lati del bacino. In questo modo le natiche non poggiano più sui calcagni, ma sul pavimento (figura b). Di conseguenza questa posizione, finché non vi sarete pazientemente esercitati ad assumerla, vi sembrerà piuttosto incomoda o dolorosa, perché le giunture, specialmente le ginocchia, non sono abbastanza elastiche: fate quindi attenzione a non sedervi di schianto, sotto pena di pericolosi stiramenti. Da principio infatti vi sembrerà quasi impossibile posare le natiche a terra: aiutatevi allora con un cuscinetto o con una coperta ripiegata, di cui diminuirete progressivamente lo spessore. Oppure poggiate le mani sul pavimento, palme in basso, ai due lati del corpo, e tendete le braccia per tenere il bacino leggermente sollevato. Con un allenamento perseverante anche questa variante dovrà diventare perfettamente agevole.
 |
| Figura b |
Una volta divenuti padroni della posizione potrete praticare vajra-âsana con stiramento del busto. Sollevate le braccia tese, descrivendo un ampio cerchio in avanti dal basso verso l’alto mentre fate una profonda inspirazione. Quando le braccia sono verticali, intrecciate le dita, rovesciate le palme delle mani verso l’alto e stirate tutto il corpo dalla vita in su come se voleste allungarlo. Si tratta dello stesso stiramento che avete appreso ad eseguire coricati in danda-âsana e che è particolarmente efficace per gli avambracci.
Durata. Vajra-âsana può essere protratto a lungo, specialmente se viene utilizzato come postura meditativa o per gli esercizi di prânâyâma. Se invece è inserito in una seduta completa si può iniziare con 30 secondi e arrivare a 3-4 minuti nella variante più difficile.
Il massaggio dell’addome. È una tecnica semplice, ma altamente benefica, che si pratica partendo dalla posizione di vajra-âsana.
Assumete innanzitutto la postura della variante facile, in cui le natiche poggiano sui talloni: chiudete gli occhi e respirate normalmente per qualche istante, concentrandovi sul ritmico movimento dell’addome. Serrate a pugno entrambe le mani, avendo cura che il pollice sia all’interno del pugno stesso, ben stretto dalle altre dita: aprite gli occhi e fate una profonda inspirazione (figura c).
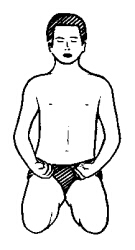 |
| Figura c |
Unite ora il più possibile i talloni, poi premete i pugni contro l’addome tra la zona pubica e l’ombelico. Espirate attraverso la bocca con una serie di soffi brevi ed energici, come se voleste spegnere la fiamma di una candela, fino a vuotare completamente i polmoni: contemporaneamente piegate il busto in avanti fino a toccare il pavimento con la fronte (figura d). Rimanete da 10 a 30 secondi in questa posizione massaggiando dolcemente l’addome con i pugni mediante un movimento rotatorio dei polsi. Inspirando, ritornate in vajra-âsana.
 |
| Figura d |
Ripetete il ciclo una seconda volta, premendo pero l’addome con i pugni all’altezza dell’ombelico e infine una terza volta con i pugni all’altezza del diaframma.
Atteggiamento mentale. Durante l’esecuzione di vajra-âsana concentrate l’attenzione sull’energia che fluisce liberamente in tutta la parte superiore del vostro corpo. Alcuni maestri suggeriscono di visualizzare un «vaso», colmo di energia, immaginando che venga rovesciato su di voi dall’alto inondandovi il capo, le spalle e il busto. Una volta assunta la postura potete anche effettuare delle impercettibili oscillazioni laterali del busto: ciò vi aiuterà a prendere coscienza del vostro «centro».
Effetti. Vajra-âsana è un’eccellente postura meditativa e ha notevoli effetti sul piano psichico: aiuta infatti a sedare l’agitazione mentale e favorisce la concentrazione.
Sul piano fisico: conferisce elasticità alle ginocchia e alle anche, prevenendone le forme reumatiche. Favorisce inoltre le funzioni digestive: la posizione può quindi essere assunta anche dopo i pasti, proprio allo scopo di agevolare la digestione.
La variante di stiramento tonifica tutti i muscoli del busto e conferisce un portamento elegante: anch’essa ha poi un’azione stimolante sull’apparato digerente.
II massaggio dell’addome è benefico per tutti i visceri ed è particolarmente indicato per le donne che soffrono di irregolarità e disturbi del ciclo mensile. è indicato anche per aiutare l’intestino pigro, ma deve essere evitato in caso di gastrite acuta o appendicite. è importante che la regola, valida per tutti gli âsana. di praticare con vescica e intestino liberi, sia attentamente rispettata: meglio quindi eseguire il massaggio con i pugni al mattino, dopo la toeletta e le funzioni corporali.
Se vi è stipsi ostinata è opportuno regolare l’intestino, qualche giorno prima di sperimentare questa tecnica, con una dieta appropriata o con un blando lassativo erboristico.
La consapevolezza del respiro (Introduzione al prânâyâma)
Prima di passare alle vere e proprie tecniche del prânâyâma, che verranno iniziate a partire dal secondo livello, è necessario, secondo quanto si è detto in precedenza, prendere coscienza dell’atto respiratorio L’esercizio seguente ha appunto lo scopo di sviluppare tale consapevolezza.
Esecuzione. Sedete in vajra-âsana o anche, se non avete ancora dimestichezza con tale postura, su una sedia, purché la spina dorsale sia ben diritta: in tutti gli esercizi di prânâyâma il dorso, il collo e la testa devono trovarsi perfettamente allineati sulla verticale (figura).
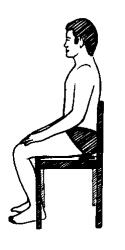 |
Prendete innanzitutto coscienza dell’inspirazione: inspirando profondamente, muovete le pinne nasali e avvertite così il flusso dell’aria che attraverso le narici penetra nel vostro corpo. Provate poi a inspirare lentamente: immaginate di seguire il cammino che l’aria, e con essa l’energia vitale, il prâna, percorre attraverso le vie nasali, la trachea, i bronchi e i polmoni. Durante questo esercizio potete anche chiudere gli occhi e visualizzare il prâna come un fluido di un vivo color corallo.
Passate ora a concentrarvi sull’espirazione: visualizzate il percorso che l’aria compie quando viene espulsa dai polmoni. Prendete coscienza anche dell’aria che vi rimane: avvertite che, per quanto profonda sia l’espirazione, non tutta l’aria viene emessa, ma una certa quantità (aria residua) rimane sempre nei polmoni.
Quando sarete divenuti perfettamente consapevoli del duplice movimento inspirazione-espirazione, portate l’attenzione sulla apnea inspiratoria, cioè la brevissima stasi che segue all’inspirazione. Visualizzate, durante questo intervallo, il prâna che dai polmoni si diffonde in tutto il vostro essere: secondo la fisiologia dello hatha-yoga questa diffusione avviene attraverso una miriade di canali sottili, denominati nadî, che però, in condizioni ordinarie, sono spesso ostruiti in parte da varie impurità. La presa di coscienza dell’atto respiratorio è il primo passo verso la purificazione delle nadî, che però, in condizioni ordinarie, sono spesso ostruiti in parte da varie impurità. La presa di coscienza dell’atto respiratorio è il primo passo verso la purificazione delle nadî, indispensabile per trarre profitto dal prânâyâma.
Concludete l‘esercizio portando l’attenzione sull’ultima fase della respirazione, cioè l’apnea espiratoria.
UN ESPERIMENTO DI OSSERVAZIONE
Vi proponiamo nuovamente un facile esperimento. Mettetevi a sedere in vajra-âsana, oppure, se siete più esperti, in padma-âsana, in un luogo appartato e silenzioso e chiudete tranquillamente gli occhi.
Rivolgete tutta la vostra attenzione all’attività della mente senza emettere giudizi di sorta, come se assisteste da spettatori disinteressati al film che viene proiettato sul vostro schermo interiore.
La prima cosa di cui diverrete consapevoli è la continua attività del mentale che proietta una pellicola illusoriamente ininterrotta: fantasie, ricordi, immagini, desideri, emozioni, verbalizzazioni, ruminazioni, proiezioni o anche sensazioni o percezioni indefinibili si avvicendano in modo apparentemente continuo richiedendo tutta la vostra partecipazione.
Secondo la Hathapradîpikâ di Svâtmarâma la mente possiede la stessa instabilità del mercurio. In molti altri testi la mente viene paragonata ad una scimmia che salta frenetica da un ramo all’altro, talora anche a un elefante infuriato che abbatte nella sua corsa cieca uomini, alberi e capanne.
In realtà, se acuite la vostra consapevolezza noterete che tra un pensiero e l’altro, tra un’immagine e l’altra, tra un’emozione e l’altra non esiste un continuum, ma un intervallo, un vuoto, cosicché il film mentale è formato da fotogrammi, alcuni dei quali sono completamente bianchi.
Se continuerete nella vostra osservazione statica noterete che il flusso mentale subisce un rallentamento: i fotogrammi diventano meno rapidi, gli intervalli vuoti aumentano e un certo silenzio incomincia a farsi strada, soprattutto se l’attività mentale non è alimentata dalle percezioni provenienti dai sensi esterni.
Al termine di questo esperimento avrete scoperto che:
a) la mente è per sua natura instabile, inquieta e vagabonda;
b) il flusso mentale, in apparenza continuo, conosce in realtà vuoti e intervalli;
c) l’osservazione del flusso ne provoca un certo rallentamento.
Una conseguenza di questa osservazione è che imparerete a poco a non identificarvi con la vostra attività mentale (l’osservatore e la cosa osservata sono distinti!) o con l’immagine di voi stessi costruita con il materiale apparentemente omogeneo di questo flusso. È probabile che di fronte ai vuoti che si interpongono tra le sequenze dei fotogrammi o all’arresto delle ruminazioni mentali proviate momentaneamente un senso d’angoscia, di colpa o di inconsistenza, come se il vostro io fosse legato al perdurare dell’attività mentale. Non impauritevi né angosciatevi, fugate ogni senso di colpa eventualmente associato al non-pensiero, imparate a gustare il vuoto e il silenzio e ad estenderli: immergetevi in essi come vi tuffaste nelle acque limpide e fresche di un lago all’alba.
Proprio per farvi acquisire maggiore familiarità con la dinamica dei vostri processi mentali esporremo in breve i principi su cui si basa la psicologia dello yoga: essa nasce da una millenaria introspezione, ed essendo frutto di osservazione empirica ognuno di voi potrà sempre verificare le affermazioni teoriche sulla base della sua esperienza personale.
TURBINI MENTALI
Secondo lo yoga la mente può essere paragonata a una distesa d’acqua dalla quale si sollevano in continuazione onde più o meno forti, che Patañjali nei suoi Yogasûtra chiama vritti, turbini o modificazioni della sostanza, mentale. La mente inferiore (manas) di solito dovrebbe compiere un lavoro di selezione e smistamento del materiale che proviene dai sensi, ma raramente essa adempie a tale incombenza con attenzione, perché la consapevolezza del presente, di ciò che è, viene in continuazione perturbata. La mente è spesso rivolta al passato e proietta inconsciamente le sue «memorie» sul presente oppure anticipa il futuro per paura dell’inaspettato, dell’ignoto.
Le onde mentali - pensieri, fantasie ed emozioni - attingono per lo più all’immenso magazzino del nostro passato (citta, l’inconscio della psicanalisi), una specie di cimitero di larve viventi che emergono come vâsanâ cioè tendenze o potenzialità latenti, e samskâra. abitudini inconsce memorizzate o complessi, che cercano di tradursi in azioni.
Gli oggetti estemi (persone, situazioni, ambienti) risvegliano o ravvivano vâsanâ e samskâra e inconsapevolmente li rafforzano, creando una catena ininterrotta di condizionamenti.
A questo proposito Ramakrishna, uno dei grandi maestri dell’induismo moderno, racconta che una giovane donna, piena di fascino, avvolta nel suo sari multicolore, passò accanto a un gruppo di asceti sprofondati in meditazione e che solo uno di loro rimase talmente colpito dalla sua bellezza da rivolgerle uno sguardo: questo perché, prima di ritirarsi dal mondo era stato marito e padre. I ricordi e le impressioni della vita coniugale e dei piaceri sessuali continuavano quindi ad agire su di lui, anche dopo anni di rinuncia e di ascesi.
D’altro canto, le nostre azioni stesse, frutto di tendenze e abitudini passate, seminano contenuti mentali sotto forma di impressioni, sensazioni, ricordi che precipitano a loro volta nell’inconscio e i cui effetti non tarderanno a farsi sentire in un futuro più o meno lontano.
Le vâsanâ, spesso identificate con i desideri o le tendenze, potrebbero meglio essere definite come le vanità umane, di cui gli antichi veggenti vedici indicavano tre tipi. Il primo è chiamato loka-vâsanâ, quel complesso di superiorità/inferiorità da cui derivano pensieri di orgoglio e separatività relativi alla classe sociale, alla religione, alla razza o alla ideologia di appartenenza. Deha-vâsana è invece l’insieme delle vanità che sono legate al corpo fisico. Coltivare pensieri del tipo: «Come sono interessante!», «Come sto bene!», «Vi piace come sono vestito?», «Come sono ingrassato/dimagrito!» e via dicendo porta all’esaltazione del narcisismo, inflazionando l’ego, e in ogni caso accentua fino all’inverosimile la preoccupazione per il proprio corpo nel senso del mantenimento della sua prestanza o della sua salute in rapporto agli altri e all’immagine che gli altri se ne fanno
Ultimo, vidya-vâsanâ, è la vanità della conoscenza, il falso senso di superiorità che proviene dall’istruzione, da un’acculturazione superficiale, da un intellettualismo privo di contenuti, dallo snobismo della cultura. In quest’epoca del sapere che si ammanta di scienza tutti siamo in maggiore o minor misura condizionati da un eccesso di propaganda e di ideologizzazione, da una scarsa informazione, da pregiudizi diffusi dai mass-media. da una sorta di lavaggio del cervello e quindi da una falsa conoscenza.
L’OSSERVATORE
Le vâsanâ accumulate nell’inconscio creano delle vere e proprie abitudini mentali di cui è difficile essere consapevoli e da cui è quindi arduo disidentificarsi; ovviamente la natura dei pensieri e dei desideri attuali dipende dai samskâra accumulati nel passato e incisi profondamente nel nostro “psiconastro”.
ecco perché lo yoga attribuisce tanta importanza alla qualità del pensiero e sostiene che noi diventiamo ciò che pensiamo: di qui la necessità, data la tendenza della mente a identificarsi e a modellarsi sul suo oggetto, di ricercare validi e positivi supporti di conoscenza che possano dilatarla, acrescerla, nobilitarla, purificarla. Se da una parte, quindi, noi non abbiamo più nessun potere sui nostri complessi e memorie passate, possiamo invece influire sulla qualità delle abitudini future, addestrando fin d’ora la mente in senso positivo.
Secondo l’osservazione di Patanjali, gran parte delle modificazioni della mente sono dolorose e fonte di conflitto, di ansia, di paura e di angoscia.
È di solito la sofferenza (klesha) che induce lo yogin a studiare i contenuti della sua mente per sradicare quelli che sono fonte di dolore e per coltivare invece quelle abitudini mentali che producono a lungo andare calma, pace, tranquillità, felicità, gioia.
Il presupposto indispensabile per predisporre una strategia atta a modificare la nostra mente è che esista qualcuno che possa diventare consapevole, che possa esservi un osservatore capace di cogliere i contenuti mentali, senza identificarsi con essi, e riorientare quindi la mente stessa. Ebbene, secondo lo yoga esiste un aspetto del nostro essere che non è identificabilele con la natura biologica (prakriti), flusso fenomenico in continua modificazione, ma è immutabile testimone e osservatore della vita, puro spirito (purusha). Di volta in volta esso viene chiamato Testimone, Spettatore, Osservatore o Colui che vede.
Come raccontano la Mundaka- e la Svetâsvatara-Upanishad, su uno stesso ramo posano due uccelli variopinti, alati amici: uno mangia i frutti dolci o amari dell’albero, salta da un ramo all’altro, becchetta inquieto, mentre l’altro osserva attentamente senza mangiare, immobile e silenzioso.
L’uccello che guarda attentamente è un simbolo del purusha, testimone silenzioso, coscienza incontaminata che trascende l’io empirico e che si riflette in una funzione più elevata della mente (buddlhi), capace di discriminare e di avere intuizioni, di riflettere ciò che non proviene dai sensi e dall’elaborazione dell’ego, ma da altri livelli e piani di realtà.
La capacità di osservare e di essere consapevoli ci permette di percepire e quindi di classificare gli stati mentali come klishta (dolorosi) e aklishtha (non dolorosi).
L’ORIGINE DELLA SOFFERENZA
La causa prima degli stati mentali dolorosi è individuata da Patanjali nella nescienza (avidyâ) o mancanza di consapevolezza della vera realtà. Essa consiste nel confondere l’effimero con l’eterno, l’impuro con il puro, il male con il bene, l’irreale con il reale, ciò che non è l’âtman con l’âtman stesso (il nostro Sé o Spirito). La nescienza fa sì che l’uomo confonda i piaceri sensibili con la gioia propria dello Spirito, rincorra insaziabilmente i piaceri sessuali, sia prigioniero della spirale desiderio-soddisfazione/frustrazione-desiderio, e consideri permanente il piano mentale e fisico che è invece soggetto a continua trasformazione. Obnubilato da essa egli dimentica che la sorgente inestinguibile della gioia (ânanda) sussista nelle profondità del suo essere anche se vi è come velata e nascosta Sorgente primaria di sofferenza, avidyâ genera a sua volta altre quattro afflizioni: asmitâ, râga, dvesha, abhinivesha.
Asmitâ è la progressiva identificazione della pura coscienza o Spirito (purusha) con i suoi veicoli grossolani e sottili di manifestazione. È come se il nostro vero io si dimenticasse di se stesso e della sua natura universale e divina e facesse tutt’uno con gli abiti indossati per la sua recita sul palcoscenico del mondo: il corpo fisico, quello emotivo e quello mentale. Da questa identificazione sorge l’ego o io empirico, la cui presenza è per altro discontinua, dissolvendosi esso momentaneamente durante gli stati di sonno profondo, di perdita patologica di coscienza, o di estasi/enstasi mistica.
Così, considerandoci tutt’uno con il nostro corpo fisico o con i corpi più sottili siamo usi affermare «lo vedo, io odo, io parlo, io cammino, io faccio, io soffro, io sono depresso, io sono felice, io penso» e così via, commettendo continuamente errori di grammatica psicologica, perché la scienza che sperimenta è distinta e non contaminata dalle esperienze provenienti dall’uno o dall’altro dei veicoli. Come ognuno può constatare sulla base della propria esperienza, l’identificazione con tutti gli stati fisici, emotivi o mentali negativi provoca sofferenza, angoscia o ansia. Infatti tutto ciò con cui noi ci identifichiamo, per una fondamentale legge psicologica, ci domina, in quanto l’io, considerandolo parte di sé, ne è coinvolto.
Proprio per questo, come vedremo nella parte dedicata agli esercizi, lo yoga insegna tecniche di progressiva disidentificazione, che permettono di disancorarsi dai vari veicoli di espressione della coscienza per poterli meglio dominare e usare con piena libertà. Tutto questo diventa possibile, però, quando si raggiunge la consapevolezza profonda che il vero centro di coscienza è diverso dall’ego o io empirico.
Râga è invece l’attrazione o passione che deriva dalle esperienze piacevoli: ma ogni soddisfazione legata a oggetti (persone, situazioni, beni, mete, progetti, ideali) è necessariamente parziale e alla fine insoddisfacente e frustrante, perché il desiderio o tensione risorge di nuovo in quanto esige una gioia illimitata. La ricerca di piaceri sensibili è la vera pena di Tantalo dell’uomo, costretto a inseguire invano il cibo e l’acqua che si ritraggono continuamente davanti a lui. Essa è in sé fonte di sofferenza, frustrazione e a lungo andare di nevrosi e genera l’attaccamento, cioè la coazione a ripetere all’infinito l’esperienza considerata potenziale fonte di piacere. Al contrario, la gioia può essere ricercata solo in direzione introversa, alla sorgente del movimento del desiderio, laddove essa è veramente esperibile in quanto è per sua natura senza oggetto.
Antidoto alla sofferenza provocata da râga è vairâgya, la rinuncia o distacco, considerata da Aurobindo «il braccio sinistro dello yoga». Il praticante deve diventare consapevole dei suoi attaccamenti e desideri, anche di quelli meno materiali e più sottili annidati nell’inconscio, e liberarsene opponendo loro un netto rifiuto psicologico. La rinunzia non deve essere vista, però, come fine, neppure deve suonare come disprezzo ascetico della vita o, peggio, come paura nevrotica del piacere. Essa è solo uno strumento e termina quando non si cerca più il piacere, perché si è sperimentata nella sua interezza la gioia del Divino.
Opposto e complementare a râga è dvesha, la repulsione verso quanto provoca sofferenza o frustrazione.
Tale repulsione può tradursi in ira (krodha) quando si presume di poter colpire, eliminare o distruggere in qualche modo quanto è avvertito come una minaccia o un ostacolo alla felicità o al piacere. Nell’ira in tutte le sue forme, dall’irritazione al risentimento, si crea sempre una contrapposizione di valore tra il proprio ego, ipervalutato per le sue qualità e i suoi meriti, e gli altri o la situazione, considerati ingiusti, malvagi, impudenti, imperdonabili perché hanno leso in qualche modo l’immagine narcisistica dell’io o si sono frapposti come ostacolo al raggiungimento di un oggetto considerato potenzialmente piacevole o gratificante. Al limite estremo la repulsione diventa odio, quando l’oggetto sembra totalmente ripugnante all’appetito o fonte di frustrazione continua. Come tale, l’odio è uno dei più potenti veleni mentali: esso inquina fortemente la coscienza, offuscandone la capacità di discriminazione, e provoca, se radicato nell’inconscio, nevrosi di ogni genere, traducendosi spesso sul piano somatico in disfunzioni e malattie. L’odio è oggi talmente diffuso che non ci accorgiamo di manifestarlo nei nostri discorsi quotidiani, quando usiamo espressioni del tipo «Non lo posso soffrire...», «Mi ha fatto venire una tale rabbia che...», «Lo ammazzerei», «Ti strozzerei», «Vai al diavolo!» e simili. D’altra parte le sue insensate manifestazioni esterne nei rapporti sociali e internazionali sono sotto gli occhi di tutti e riempiono le cronache del nostro secolo: violenza, omicidi, terrorismo, genocidi, guerre.
Invero solo la pratica di yama, in modo particolare di ahimsâ (non-violenza), satya (verità) e asteya (astensione dal furto), costituisce un antidoto efficace contro la repulsione, l’ira e l’odio. Solo però quando si considera la vera natura dell’altro, che è identica a quella del nostro stesso sé, ogni repulsione cade e nasce il desiderio di essergli di aiuto in tutti i modi possibili.
Ultimo prodotto della nescienza è abhinivesha, l’estrema volontà di vivere che domina tutti gli esseri come istinto di conservazione individuale. Secondo Vyâsa, il principale commentatore antico di Patanjali, questo tenace attaccamento alla vita sarebbe da collegarsi alla paura della morte e, poiché tale paura è giustificata solo in chi ne ha già fatto precedente esperienza, ciò sarebbe una riprova dell’esistenza di vite passate e della reincarnazione.
In ogni caso l’istinto di conservazione a oltranza è fonte di sofferenza perché in definitiva è affermazione dell’ego e dei suoi desideri in contrapposizione agli altri e a tutto ciò che si presenta come ostacolo e limite spiacevole dell’io stesso. Tale affermazione dell’ego è all’origine di molte nevrosi e comportamenti patologici se non viene superata e sublimata.
Il rinnegamento dell’ego, che vuoi dire da un lato distruzione dell’attaccamento all’esistenza e dall’altro estinzione della paura della morte, costituisce il cardine di ogni vera sapienza psicologica e religiosa e passaggio obbligato verso la liberazione e realizzazione del Sé.
LA SOPPRESSIONE DELLE MODIFICAZIONI MENTALI
Secondo la nota definizione di Patanjali il fine dello yoga è quello di sopprimere le modificazioni mentali. Ciò deve essere inteso, però, non soltanto come l’arresto del flusso di pensieri, emozioni, fantasie, desideri, ma anche come sradicamento di quelle potenzialità o tendenze latenti che generano nuove correnti mentali o nuove linee di azione. Qui lo yoga si colloca agli antipodi della psicanalisi: se per quest’ultima esistono fatti psichici normali e altri patologici, per lo yoga tutti gli stati di coscienza ordinari, per quanto psicologicamente reali, sono falsi e patologici da un punto di vista metafisico. Difatti ogni esperienza psicologica nasce dall’ignoranza della vera natura del sé.
Quindi, mentre la psicanalisi non persegue come obiettivo primario l’interruzione del circuito inconscio-coscienza e la distruzione del flusso psichico ordinario basato sulla catena delle associazioni, ma solo la catarsi di quei fattori patologici che inceppano perché inconsci la dinamica «normale» della psiche, lo yoga parte proprio dal presupposto che solo annichilendo il flusso mentale e bloccando il rapporto condizionante tra inconscio e coscienza è possibile raggiungere la vera, normale coscienza che è coscienza del sé.
La distruzione dei turbini mentali non vuoi dire però rimozione degli stessi (in questo yoga e psicanalisi coincidono); essa si attua solo conoscendo la causa, il contenuto e le implicazioni profonde di ciò che è destinato alla distruzione e questo è possibile attraverso una sperimentazione degli stati di coscienza ottenuta per mezzo di una tecnica precisa.
Apparentemente lo yogin il quale, seduto in una comoda postura, nella quiete e nel silenzio della sua stanza, osserva in piena libertà da dove provengono, dove cercano di andare, come si modificano, che cosa provocano i vortici della sua coscienza, fa la stessa cosa dell’analizzato disteso sul lettino dell’analista.
C’è però una differenza fondamentale. Durante l’analisi le emozioni, le fantasie, i ricordi con i loro riflessi somatici vengono indotti nella particolare situazione del transfert, cioè in quel complesso di emozioni particolarmente intense che il paziente proietta sull’analista. Spetta poi a quest’ultimo interpretare il materiale inconscio in modo che il paziente prenda coscienza di ciò che ha rimosso dalla sua coscienza ordinaria o ha completamente dimenticato.
Nello yoga invece l’osservazione è diretta verso tutto ciò che liberamente affiora alla coscienza per mezzo delle modificazioni fisiologiche indotte con il prânâyâma, verso i contenuti osservabili in uno stato molto simile a quello di sonno cosciente.
L’analogia apparente tra le due pratiche è abbastanza evidente: l’uomo può liberarsi solo conoscendo concretamente, sperimentando. La catarsi è possibile solo rivivendo intensamente una situazione o un conflitto e, al tempo stesso, osservandoli consapevolmente. Come si vede, nello yoga l’analista e l’analizzato, l’osservatore e l’osservato convivono nella coscienza del praticante.
Ma l’indagine del flusso che proviene dall’inconscio e anche dalle esperienze attuali dei sensi sarebbe destinata a procedere all’infinito, perché quand’anche i vortici attuali fossero distrutti, altri ne sopravverrebbero tratti dalle considerevoli riserve di latenze che giacciono nell’inconscio, quei vâshana e samskàra di cui abbiamo già parlato. Se si vuole quindi distruggere le cittavrtti occorre interrompere il circuito tra inconscio e coscienza.
LA CONCENTRAZIONE (DHÂRANÂ)
È il mezzo che vi permette di sbarrare il flusso mentale alimentato sia dall’attività inconscia di vâsana e samskâra sia delle informazioni provenienti dagli organi di senso.
Come la superficie di un lago può essere perturbata da ciò che si trova sotto di essa o da agenti esterni, così la mente può essere mossa sia da ciò che proviene dall’interno (inconscio) sia da ciò che giunge dall’esterno (percezioni sensoriali). La concentrazione (dhâranâ) è come una diga o sbarramento contro cui si infrangono invano le onde sollevate dagli agenti interni ed esterni.
Essa consiste nell’interrompere il flusso di coscienza basato sulla catena di associazioni fermando per un periodo determinato la mente su un unico soggetto esterno o interno, a cui essa deve essere costantemente riportata per tutto il tempo dell’esercizio.
All’inizio risulta particolarmente arduo mantenere l’attenzione su un unico oggetto, perché la mente tende a vagare e a proseguire nel suo movimento inerziale. Anzi, ogni tentativo troppo brusco o violento di circoscriverne l’attività fa insorgere meccanismi di difesa (stanchezza, noia, ansia, fantasticherie), come se l’inconscio o la mente giudicassero pericoloso qualsiasi tentativo di disciplina o raffrenamento e volessero quindi sabotarlo.
Ma la pazienza, una volontà temprata e una tenacità instancabile avranno ragione di qualsiasi difficoltà e resistenza, purché coltiviate la convinzione che i vostri sforzi avranno presto o tardi successo.
Affinchè tale suggestione sia più accettabile e quindi efficace diremo in breve quali sono i vantaggi e i poteri che essa dona.
La concentrazione vi permetterà anzitutto di purificare la mente, placando le vostre emozioni e dando chiarezza e lucidità alle vostre idee, e in secondo luogo di renderla penetrante come un laser. Naturalmente la pratica sarà enormemente avvantaggiata se sostenuta dalla osservazione di yama e niyama che devono essere considerati non come precetti astratti ma come prerequisiti, verificabili ed empirici, per ottenere qualsiasi risultato positivo nello yoga.
Inoltre la concentrazione fornisce dei reali poteri quali:
- la capacità di conoscere l’essenza dell’oggetto su cui ci si concentra
- il miglioramento della volontà, che diviene quindi abbastanza forte da ottenere ciò che prima esorbitava dalle sue possibilità di acquisizione
- la possibilità di divenire ciò che si è scelto di essere; per esempio ci si può trasformare in individui forti e coraggiosi da timidi e deboli, acquisire calma e pace inferiore, aumentare il grado della propria consapevolezza
Naturalmente tutti questi poteri devono essere visti non in funzione dell’ego, ma come strumenti per realizzare il Sé o il Divino.
Negli esercizi di concentrazione vi saranno di valido aiuto alcune pratiche preliminari che ridurranno progressivamente le oscurità, i vagabondaggi e l’inerzia della vostra mente. Tra quelle che gli istruttori spirituali consigliano, si segnalano come particolarmente efficaci le abitudini seguenti:
a) coltivare un atteggiamento mentale di benevolenza e di compassione verso tutti gli esseri e in particolare verso le persone che si trovano in difficoltà in modo da produrre in se stessi, insieme a comportamenti conformi, serenità ed equanimità;
b) osservare il silenzio per un periodo determinato (questa era una delle pratiche basilari di Gandhi che lo manteneva per un giorno alla settimana); tale pratica rafforza enormemente la capacità di parlare e l’efficacia della parola stessa;
c) praticare sistematicamente l’isolamento per qualche ora durante il giorno, all’aperto o in una stanza, per dedicarvi a esercizi di osservazione inferiore, a letture scelte attinenti alla pratica, al miglioramento delle posture per la meditazione, alla preghiera o alla contemplazione;
d) prendere coscienza, in qualsiasi istante ciò sia possibile, che siamo egocentrici (= centrati sull’ego) e che pensieri, emozioni e azioni hanno origine dal desiderio illusorio dell’io di affermarsi e di espandersi come entità e di nascondere a sé e agli altri la propria discontinuità e inconsistenza;
e) interrompere ogni volta che ne siete consapevoli il dialogo inferiore, il continuo chiacchierio con voi stessi, la fantasticheria e l’ideazione senza meta;
f) praticare quotidiani esercizi di prânâyâma facile (che non comportano alcun rischio fisiologico e psicologico se si rispettano le regole fondamentali della non-violenza, del non-sforzo, della gradualità e della consapevolezza) come il vibhâga-prânâyâma, il mahâ-yoga-prânâyâma, e il pranava-prânâyâma;
g) eseguire il pratyâhâra, cioè il ritiro dei sensi dai rispettivi oggetti, mediante la tecnica di yoni-mudrâ.
I SUPPORTI DELLA CONCENTRAZIONE
Una volta predisposta la mente, dopo averla resa abbastanza docile e averla purificata per mezzo delle pratiche preliminari sopra indicate, è di somma importanza la scelta del supporto da utilizzare per la concentrazione. Esso deve essere gradevole e potenzialmente stimolante per l’elevazione e l’ampliamento della mente. All’inizio consigliamo di praticare la concentrazione su oggetti esterni che tocchino i sensi e solo in un secondo momento di ricorrere a supporti interni fisiologici o psichici.
Se decidete di utilizzare la vista, potete scegliere per cominciare un oggetto naturale come un frutto, un fiore, un albero, una cascata, un corso d’acqua, la fiamma di una candela oppure, in mancanza d’altro, la lancetta dei secondi del vostro orologio.
Posto l’oggetto di fronte a voi, una rosa ad esempio, sedete in una postura adeguata (vajra-âsana o padma-âsana) in un luogo appartato e ben illuminato e respirate tranquillamente: posando gli occhi sul fiore contemplatene la forma, il gambo, le foglie, la corolla, i petali, i sepali, le gocce di rugiada, il colore, aspiratene per qualche istante il profumo, ma evitate che attraverso il meccanismo delle associazioni la mente cominci a vagabondare e a portarvi lontano dall’oggetto stesso. Se ciò succede riportate la mente con fermezza sul supporto da voi scelto, evitando perciò di lottare con la mente stessa e di far insorgere qualsiasi tensione fisica o psicologica: ricordatevi che state facendo un esperimento con voi stessi e che tutto ciò è quasi un gioco!
Dagli oggetti potete passare in un secondo tempo alle figure: potete utilizzare delle immagini sacre o icone, se siete devoti e religiosi, oppure dei simboli che siano per voi altamente significativi.
In questa seconda fase, dopo aver fermato per un po’ lo sguardo e la mente sulla figura, potete provare a chiudere gli occhi per alcuni istanti cercando di visualizzare l’immagine nel modo più vivido possibile.
Un altro tipo di concentrazione può essere eseguito su alcuni versetti delle scritture (Salmi, Vangelo, Upanisad, Bhagavadgîtâ) o su un pensiero dei grandi maestri spirituali.
Leggete ripetutamente ad alta voce il passo prescelto (che deve essere all’inizio molto breve), memorizzatelo e riportate su di esso la vostra mente durante un’intera giornata anche in mezzo alle occupazioni quotidiane.
II supporto da utilizzare nel passaggio all’uso dei punti di concentrazione interni è il respiro. Tutti gli istruttori spirituali invitano a diventare consci del proprio respiro mentre si è in piedi o seduti, mentre si passeggia, si mangia, si agisce o quando si è in preda a qualche emozione spiacevole. La consapevolezza del respiro, infatti, alleviando la tensione tra la mente ed il corpo e riducendo lo spreco di energia dissipata nel conflitto aumenta il grado di rilassamento e quindi lo stato di benessere psicofisico.
II collegamento della mente al respiro, quando diventa abitudine senza sforzo, è uno dei modi più semplici per tranquillizzare l’intero nostro essere ed eliminare gli stati di ansia o di angoscia che di solito producono una inibizione nella funzione respiratoria. Inoltre, attraverso l’attenzione al respiro ognuno può diventare conscio della qualità del suo rapporto con il mondo e con gli altri, in quanto l’inspirazione rappresenta simbolicamente ciò che riceviamo dal Divino, ciò che prendiamo dal mondo e dagli altri, l’introiezione della realtà, mentre l’espirazione è un simbolo di restituzione, della capacità di dare e donarsi e, in ultimo, di quel processo definitivo di resa che è la morte.
I CAKRA
Oltre che sul respiro e sugli âsana, quando vengono mantenuti per un certo tempo, la concentrazione sul piano inferiore viene di solito esercitata su alcuni punti speciali detti cakra, che sono al tempo stesso dei centri fisici, essendo associati a plessi nervosi o a ghiandole endocrine, e centri psichici, veri e propri canalizzatori di energia tra i corpi sottili e il corpo denso.
Secondo la fisiologia «psichica» dello yoga i cakra, sette di numero, sono localizzati nel corpo sottile lungo la colonna vertebrale dal perineo alla sommità del cranio e sono collegati da canali sottili (nadî) attraverso i quali circola il prâna.
Essi sono raffigurati come fiori di loto, ognuno dei quali è contraddistinto da un certo numero di petali e da un colore ed è sede di un elemento; inoltre ogni cakra possiede una sua sillaba sacra (bîja-mantra), ed è fornito di certe qualità o poteri.
Il centro inferiore, situato nella zona tra i genitali e l’ano, è il mûladhâra-cakra, rappresentato come un loto di quattro petali rosso cremisi. Nella corolla del fiore è situato un quadrato di colore giallo in cui campeggia un elefante fornito di sette proboscidi a simbolo della stabilità e solidità dell’elemento terra. L’animale sorregge sulla groppa un triangolo rosso (la triplice energia di volontà, conoscenza e azione) con il vertice rivolto in
basso dove è disegnato un linga (fallo), simbolo del divino generatore: attorno ad esso è attorcigliato un serpente aureo (kundalinî) che rappresenta l’energia primordiale indifferenziata.
La concentrazione su questo cakra, che può essere eseguita inizialmente sul suo yantra (un quadrato giallo su fondo nero), apporta quiete al corpo fisico.
Il cakra successivo ha nome svâdhishthâna, un loto di sei petali vermigli posto all’altezza degli organi genitali che contiene una mezzaluna madreperlacea e un mostro simile all’alligatore, anch’esso bianco. Tale centro, collegato all’acqua, corrisponde a livello fisico agli organi di escrezione e riproduzione, mentre sul piano psichico è sede dell’inconscio personale e collettivo, serbatoio degli archetipi o memorie ancestrali.
Durante la concentrazione può essere visualizzato come una mezzaluna brillante sul fondo cupo del cielo oppure come la vasta distesa di un oceano oscuro perennemente agitato; attraverso la sua purificazione, anche mediante l’osservanza del brahmacarya, è possibile controllare e dominare le pulsioni sessuali, il desiderio di potere e di autoaffermazione, la crudeltà, le proiezioni persecutorie, la credulità.
Legato al fuoco è il manipûra-cakra, situato nella regione un po’ al di sopra dell’ombelico, un loto dai dieci petali giallo lucenti contenente un rosso triangolo rovesciato con tré svastiche all’interno del quale si trova un ariete.
Sul piano denso il manipûra-cakra corrisponde al plesso solare, è il deposito dell’energia nervosa o vitalità fisica e presiede ai processi di digestione e assimilazione del cibo, oltre a controllare la secrezione delle ghiandole surrenali, particolarmente attive nelle situazioni di emergenza.|
La meditazione su questo centro e sul plesso corrispondente è quindi particolarmente efficace per aumentare il controllo emozionale, stimolando le emozioni positive e inibendo quelle negative, accrescere la vitalità e la forza psichica, correggere gli eventuali disturbi dell’apparato digerente.|
Tutte le persone che soffrono di astenia, depressione, paura, incostanza, timidezza o disturbi dell’apparato digerente potranno trarre quindi giovamento dalla concentrazione su questo cakra.
Nella regione del cuore di trova I’anâhata-cakra, i cui tredici petali sono di colore rosso vermiglio. Esso racchiude un esagramma costituito da due triangoli intrecciati di color azzurro fumo, simbolo dell’elemento aria, dove campeggia un antilope nera.
Sul piano fisico il centro è associato al cuore, ai polmoni e ai sistemi circolatorio e respiratorio. Potranno quindi trarre giovamento dalla concentrazione su di esso, effettuata preferibilmente durante la pratica degli âsana, sofferenti di ipertensione, aritmie, tubercolosi, asma e bronchite.
II cakra potrà essere visualizzato come un esagramma azzurro su fondo nero, oppure come una caverna o cavità all’interno del torace nella quale arde una fiamma costante come in un luogo senza vento, simbolo dell’anima individuale (jîvâtman), imperturbabile alle vicissitudini e ai mutamenti mondani.!
Sulla spina dorsale, a livello della gola, si trova il vishuddhi-cakra, costituito da un loto di sedici petali di color porpora scuro. Esso contiene un cerchio bianco inscritto in un triangolo con il vertice rivolto in basso, in cui campeggia un elefante pure bianco.
Poiché sul piano fisico tale cakra influenza le corde vocali, la laringe, la tiroide, le paratiroidi e il plesso cervicale, la concentrazione su di .esso avrai effetti terapeutici per tutti i disturbi e le malattie che interessano questa regione del corpo.
II centro potrà essere visualizzato come un ovale nero o indaco scuro (blu argenteo scintillante come il colore puro del mare) prima esternamente, in un secondo momento internamente sulla spina dorsale all’altezza del pomo d’Adamo.
Nel punto tra le sopracciglia è collocato l’ajna-cakra, un fiore di loto con due petali bianchi, che reca al suo interno il mantra OM: è un centro molto importante perché è il ponte di comando della coscienza individuale, della consapevolezza e delle facoltà mentali.
La concentrazione su questo cakra permette di ottenere rapidamente il controllo dei centri nervosi e particolari esperienze spirituali, in quanto esso è come una porta che si apre su livelli più alti e profondi di consapevolezza. Intelligenza, memoria, volontà e concentrazione saranno inoltre accresciuti attraverso la stimolazione e il risveglio dell’ajna-cakra.
Alla sommità della testa vi è poi l’ultimo centro, il sahasrâra, considerato non un cakra vero e proprio, ma la sede della coscienza più elevata.
Esso è rappresentato come^un fiore di loto luminoso dai mille petali al centro del quale si trova lo Siva-linga simbolo della pura consapevolezza.
E in questo loto che la shakti, l‘energia latente simile a un serpente di fuoco, s’incontra nella sua risalita col purusha, lo Spirito, immergendosi nella sorgente da cui è venuta: qui materia ed energia si fondono con la pura coscienza e l’anima individuale si riassorbe nell’anima universale in una esplosione di gioia senza limiti.
LA MEDITAZIONE (DHYÂNA)
Quando la concentrazione diventa stabile e si crea un flusso ininterrotto di coscienza verso il supporto (interno o esterno) utilizzato come ancoraggio, la mente compie un salto qualitativo ed entra nello stato di meditazione. In esso gli ultimi ostacoli e difficoltà che potevano disturbare la concentrazione scompaiono e la coscienza diventa luminosa, toccando uno stato di vigilanza e di intensità superiore a quello dello stato normale di veglia, mentre la quiete e la pace pervadono l’essere del meditante. Mentre la stessa respirazione si fa più sottile e svaniscono la sensazione di avere un corpo e le percezioni sensoriali esterne, emerge in primo piano la vibrante energia della coscienza, come se l’intera realtà del soggetto si trasformasse in un’unica onda di luce.
Naturalmente il successo nella meditazione richiede una lunga disciplina per ottenere il controllo della mente e delle emozioni e per creare una significativa armonia inferiore oltre che esterna: solo allora sarà possibile dirigere in modo cosciente la mente e il pensiero stesso. La corrente di pensiero unificato che si realizza nella meditazione non è diretta verso un oggetto ordinario ne si svolge a livello della mente ordinaria: l’oggetto infatti dev’essere ideale o spirituale ed è, in ultimo, il Divino in uno dei suoi aspetti; la facoltà interessata è la buddhi, la mente superiore capace di riflettere lo Spirito e di avere intuizioni della Verità.
Per realizzare questo continuum e accedere al livello superiore di coscienza è necessario anzitutto preparare il terreno e cioè svuotare la mente, rigettando tutti i pensieri futili, inutili o degradanti, in una parola negativi, ma anche quelli che nascono dalla dualità e dalla separatività.
Solo quando la mente sarà libera dai meccanismi coatti di pensiero e avrà la possibilità di pensare o di non pensare a suo piacimento, di volgere nella direzione voluta la sua attività o di trascendere il pensiero stesso verso la Verità pura, avrà l’energia necessaria per praticare la meditazione.
Si richiede quindi in primo luogo una grande concentrazione della volontà per vincere quanto ostacola la meditazione, come il vagabondaggio mentale, la sonnolenza, il nervosismo, la pigrizia.
In secondo luogo, attraverso l’osservanza costante di yama e niyama, è necessario purificare e placare la mente profonda (citta), liberandola dalle emozioni perturbanti come la depressione, l’ansia, l’ira, le preoccupazioni quotidiane.
Ciò che conta quindi non sono tanto le condizioni esterne (la solitudine e l’isolamento in un ambiente adatto non sono di per sé impossibili) quanto le predisposizioni mentali e morali, che esigono uno sforzo costante e un’attenzione quotidiana fino a quando l’abito meditativo non si è pienamente instaurato.
Secondo la bella immagine della Mundaka-Upanisad la meditazione si può paragonare alla pratica del tiro con l’arco in cui tre sono i fattori da considerare: il bersaglio, l’arco e la freccia.
Anzitutto occorre individuare il bersaglio e questo è il brahman, l’Eterno, il Divino. Poi è necessario tendere l’arco, l’insegnamento ricevuto, per mezzo della mente che è giunta alla comprensione spirituale, incoccando la freccia, il nostro vero sé o âtman.
Per centrare il bersaglio è indispensabile anzitutto che l’arciere fornisca un impulso sufficiente al dardo attraverso un’adeguata tensione dell’arco e della corda e, in secondo luogo, calcoli la traiettoria esatta attraverso una mira precisa: ma queste due condizioni devono essere assolte prima di scoccare la freccia, pena il fallimento del bersaglio stesso.
Così il meditante deve mirare bene al suo «bersaglio» spirituale e tendere la mente con tutta l’energia a sua disposizione per scoccare se stesso verso il Divino.
Come la freccia si conficca nel bersaglio, così il meditante si immerge nell’oggetto della sua meditazione e come l’arco si separa dalla freccia, così alla fine, quando la mente è assorbita nel Divino, cade anche la coscienza del corpo e del mondo esterno.
Allo stesso modo dell’arciere, che all’infuori della pratica si dedica a esercizi fisici per irrobustire il suo corpo e tendere con maggiore facilità l’arco e ad esercizi mentali per aumentare il suo grado di concentrazione, così lo yogin deve costantemente perfezionare il suo strumento per meglio utilizzarlo nella meditazione.
Il lavoro psicofisico del meditante deve procedere in quattro direzioni per armonizzare il corpo, le emozioni, il pensiero e la volontà.
Il veicolo fisico dev’essere convenientemente preparato attraverso la pratica di âsana e prânâyâma e, se possibile, anche da una dieta adeguata che escluda la carne, per lo meno quella vaccina e suina, e ogni genere di eccitanti nervini. Inoltre, attraverso tecniche di rilassamento, esso deve raggiungere uno stato di quiete e di silenzio. In particolare, durante la seduta di meditazione si potrà utilizzare una delle posizioni che ingenerano stabilità e fermezza come vajra-âsana, siddha-âsana, o padma-âsana, poiché le emozioni sono il fattore più disturbante e prevalgono talora sul pensiero stesso (durante la meditazione si è spesso assaliti da fantasie, ricordi, desideri i più stravaganti) occorre coltivare come antidoto una mente compassionevole e benevola, animata da un intenso desiderio di essere di beneficio a tutti gli esseri e di promuoverne con ogni mezzo lo sviluppo sia fisico che psichico e spirituale. Tale attitudine sarà rafforzata se vi abituerete a considerare che il Sé, il sole divino, è uno in tutti e tutti sono immersi nella sua luce e nel suo amore. Inoltre dovrete trasmutare i vostri sentimenti di ostilità verso chicchessia, se ce ne fossero, in irradiazioni di compassione, benevolenza e benedizione. Tale atteggiamento diventa, nel momento specifico della meditazione, offerta dei risultati della pratica a beneficio di tutti gli esseri, poiché noi non meditiamo per noi stessi, ma per tutta l’umanità.
Sul piano della emozionalità complessiva è poi di grande vantaggio coltivare un grande senso di devozione verso il Divino, cercando di scorgerne sempre e dovunque la presenza con amore e gratitudine.
A livello del pensiero dovete coltivare il senso della vostra vera identità, disidentificandovi dal corpo e dalla mente e ripetendo o ricordando spesso a voi stessi: «lo sono lo Spirito eterno e gioioso; lo sono il Sé, puro Essere, pura Coscienza, pura Gioia; lo sono Luce eternamente risplendente». In tal modo si creerà l’abitudine a dirigere in modo consapevole il flusso del pensiero.
Infine, è possibile esercitare la volontà imparando a vincere ogni giorno qualche difetto o qualche debolezza dicendo a se stessi: «lo voglio superare la tale debolezza o abitudine... lo so che posso liberarmene completamente e rapidamente... lo posso e lo voglio... lo ho una grande fiducia in me stesso e nella mia forza di volontà che cresce .ogni giorno di più... Io posso sradicare questa abitudine... Essa mi abbandona... O Tu che sei il mio alto Sé, che sei Forza e Potere inesauribile, vieni in mio aiuto».
Quando gli strumenti psicologici saranno pronti e la volontà sarà stata rafforzata, sarà possibile al momento opportuno distogliere la mente dagli oggetti esterni e dal flusso di idee ed emozioni interne e concentrarla in un punto solo, mantenendovela per tutta la durata voluta.
Rientrando in noi stessi incominciamo un lungo viaggio per cercare la Verità e il nostro vero lo: questo corpo è la città del brahman, la città del Divino, e in questa immensa città c’è una casa con un piccolo spazio vuoto. In esso sono riuniti e compresi il cielo e la terra, il sole e la luna, le galassie e le costellazioni, tutto ciò che ognuno possiede sulla terra e sulla terra desidera, perché in esso risiede l’âtman che non conosce peccato né nascita ne decadimento né morte né dolore né fame né sete.
Cercare questo âtman, realizzare questo âtman, essere questo âtman è lo scopo e la meta della vita, perché da esso tutte le nostre aspirazioni e desideri sono soddisfatti e in esso si trova quanto vanamente cerchiamo nel mondo esterno. Quando questo avverrà scopriremo che il nostro Vero lo e Dio sono Uno:
«Nel più profondo di te stesso. Anima, tu sei Quello; giorno verrà in cui lo realizzerai da tè; quel giorno arriverà sicuramente, poiché lo sono il fine certo della vita dell’Anima; ricordati, ricordati sempre che lo sono con te; lo sono con te; considerami come la forza per la tua debolezza; come la misericordia per i tuoi peccati; come l’Amore quando mi cerchi, lo sono il tuo lo, lo sono il tuo lo. Non accettare altra concezione di Me, perché tutta l’ignoranza e tutta la debolezza del mondo risiedono nel pensiero che ci possa essere differenza tra il tuo lo e il mio lo; alzati dunque, o Risplendente, e sappi che lo sono il tuo vero lo; lo sono il tuo vero lo».
Sedete in modo rilassato e con gli occhi chiusi in una delle posture di meditazione che avete imparato, con la spina dorsale ben diritta, la nuca, il collo e la testa su una stessa linea. Siate presenti a voi stessi, ma senza tensione. Portate ora la vostra attenzione sul flusso del vostro respiro, là dove esso entra ed esce dalle narici. Quando la vostra concentrazione sul respiro si è stabilizzata, contate 21 respirazioni computando per 1 l’inspirazione e l’espirazione successiva. Eseguite un primo ciclo di 21 respirazioni, poi aumentate gradatamente di uno o più cicli nel corso dei giorni. Al termine della seduta offrite i frutti della vostra meditazione a beneficio di tutti gli esseri.
Osserverete un progressivo aumento della calma e della pace inferiore e una riduzione notevolissima dell’ansia e dell’agitazione. Dedicate se possibile a questo esercizio due sedute giornaliere, al mattino e alla sera, per alcuni mesi estendendone progressivamente i tempi.
Meditazione sul grembo universale (yoni-mudrâ)
Sedete in una confortevole postura meditativa, inspirando ed espirando lentamente. Portate le mani davanti al viso, mantenendo i gomiti sulla stessa linea delle spalle e ad angolo retto rispetto al corpo. Chiudete quindi gli orecchi con i pollici e gli occhi con gli indici senza premere, appoggiate i medi sul naso senza bloccare il passaggio dell’aria e infine collocate glj anulari e i mignoli sopra e sotto le labbra a simboleggiare la chiusura della bocca.
Quando tutte le aperture dei sensi saranno simbolicamente chiuse, indirizzate la vostra attenzione ai suoni interni: il battito del cuore, il flusso del respiro, la circolazione del sangue, fino ai suoni più sottili che potete percepire. Mantenete questa mudrâ per 10-15 minuti, poi lentamente togliete le mani dal viso, aprendo gradualmente gli occhi.
In una seconda fase più avanzata inspirate profondamente e chiudete con i medi le narici, mantenendo le altre dita nella posizione indicata prima.
Rimanete qualche secondo in apnea inspiratoria sempre con l’attenzione rivolta ai suoni interni, poi espirate. Ripetete il processo diverse volte.
Questo esercizio è considerato un potente aiuto al pratyâhâra, cioè al ritiro dei sensi dagli oggetti esterni e al loro controllo.
Esso conferisce uno stato di calma e di serenità perché la mente ha la possibilità di isolarsi da tutto ciò che all’esterno può disturbarla e l’energia nervosa, soprattutto quella utilizzata nella vista, non essendo dissipata all’esterno può essere riorientata per acuire la capacità di attenzione psichica.
Durante la pratica dovrete immaginare di sprofondare nel grembo universale (yoni) pensando che il Divino vi accoglie e vi sostiene con amore da ogni lato proprio come una madre tiene tra le braccia il suo bambino.
Concentrazione sulla fiamma (trâtaka)
Sedetevi in una postura meditativa, in una camera buia. Collocate davanti al vostro viso alla distanza di un metro una candela accesa e rilassatevi completamente, osservando soprattutto che non ci siano tensioni dietro la schiena, all’altezza delle spalle e sul collo. Fissate senza sforzo o tensione la fiamma cercando di non sbattere le palpebre. Quando effettuate l’esercizio i primi giorni non superate i 15-30 secondi, poi aumentate gradatamente i tempi. Dopo aver effettuato il trâtaka chiudete gli occhi e cercate di visualizzare la fiamma della candela dentro di voi per lo stesso tempo impiegato nella contemplazione ad occhi aperti. Ciò sarà facilitato dalla persistenza dell’immagine retinica, ma se per caso non riusciste, agli inizi potete socchiudere di tanto in tanto gli occhi per osservare la fiamma.
Questa stessa pratica potrà essere estesa al disco del sole nascente oppure alla fotografia del vostro maestro spirituale o a un’icona, cercando di avvertire in questo caso la presenza spirituale del maestro stesso o la grazia e l’amore del Divino, se si tratta di un’immagine.
Dal punto di vista fisico avvertirete notevoli benefici agli occhi, di cui l’esercizio corregge alcuni difetti e, poiché gli occhi sono lo specchio dell’anima, anche la mente diventerà più stabile e calma, permettendo di dare sollievo anche ai casi di insonnia più ostinati.
Sedete in una postura meditativa. Respirate profondamente e liberamente cercando di abbandonare ogni tensione sia fisica che psichica. Portate ora la vostra attenzione sull’ombelico e, durante l’inspirazione, immaginate di far salire il respiro in alto fino all’ajna-cakra, il centro fra le sopracciglia. Occupandovi del percorso dal basso verso l’alto dell’inspiro, eseguite un certo numero di respirazioni per 5-10 minuti.
Quando vi sentirete rilassati e calmi, tracciate intorno alla vostra testa un cerchio immaginario e visualizzatelo come uno spazio silenzioso, come un campo di neve sulla cima di un’alta montagna. Immaginate ora che tutti i pensieri, tutte le fantasie e le formazioni mentali provengano dall’esterno e cerchino di penetrare nello spazio silenzioso della vostra coscienza.
Quando vi accorgete che un qualche pensiero, sotto forma di verbalizzazione o di immagine o di ricordo o di pulsione, tenta di entrare nello spazio in cui idealmente vi trovate come osservatori, allontanatelo con fermezza A mano a mano che la vostra attenzione si farà più acuta, potrete diventare consapevoli delle formazioni mentali allo stato nascente sempre come provenienti dall’esterno. Ogni qualvolta le onde del pensiero cercheranno di superare la barriera del cerchio, fate come un gesto inferiore di arresto o di spegnimento.
Procedete in questa osservazione e svuotamento dello spazio mentale per 15 minuti o più fino a quando uno stato profondo di silenzio non regnerà in voi.
Quando ciò sarà avvenuto, immaginate che una luce dorata e viva, come una danza di pulviscolo d’oro in movimento, scenda sul vostro capo, visualizzato come una corolla che si spalanca per accoglierla.
Associate la luce alla gioia e alla pace e rimanete immobili nel silenzio ancora per un certo tempo (10 o 15 minuti agli inizi), poi respirando profondamente riaprite lentamente gli occhi.
Sedete tranquillamente in una postura meditativa e prendete coscienza de vostro respiro. Poi concentratevi sulla parola pace o, se preferite, shânti in sanscrito, evocatene tutto il significato e il valore, associando a essa le vostre eventuali esperienze di pace profonda. Quindi ripetete mentalmente la parola durante l’inspirazione e l’espirazione successiva, immaginando a ogni inspirazione di riempirvi di pace e a ogni espirazione di diffondere una pace sempre più profonda in ogni parte del vostro essere, a cominciare dal vostro veicolo fisico fino alle emozioni, alla mente e allo spirito. Lo stesso esercizio può essere praticato associando al respiro la ripetizione di gioia/serenità/amore/letizia.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione del testo in qualsiasi forma senza permesso dell’editore, salvo nel caso di citazioni o di recensioni, purché quanto in esse riportato sia conforme all’originale e se ne citi la fonte.
|
Via Malta, 36/8 - 10141 Torino Tel. 011-3821049 - Fax 011-3821196 |